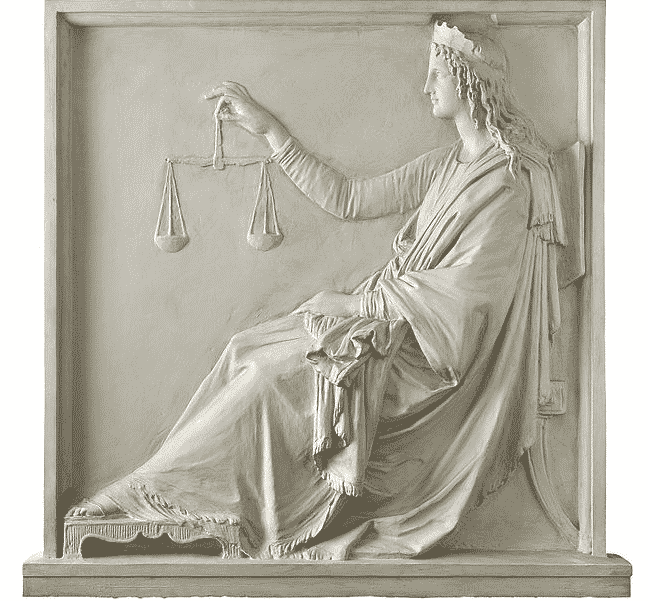
I beni comuni, la proprietà e la rinunciabilità della proprietà sono argomenti di studio alquanto controversi e molto affascinanti, anzitutto per il loro spessore scientifico di carattere sistemico.
Filosofi, economisti, giuristi romanisti studiosi delle res communes omnium e giuristi civilisti hanno condotto degli studi sulla identità e sulle caratteristiche dei beni cosiddetti “comuni”, dei beni collettivi, delle proprietà collettive, delle comunioni a mani riunite, germaniche, e di quelle romanistiche, ponendo alcuni criteri distintivi basati ora sulla logica, ora sullo studio delle fonti legali storiche.
Nella dottrina politologica, più che altro, la nozione di bene comune è associata alla teorica delle risorse comuni (commons), spesso in sintonia con esigenze concrete di tutela dell’ecosistema, in una considerazione informale e non-giuridica dell’economia. Gli studiosi sono fermi per lo più su posizioni che identificano questi beni attraverso i caratteri della non escludibilità e della non sottraibilità, ora in un entroterra statalistico, ora in seno ad una cultura liberistica, ora in un’ottica temperata di tipo socio-empirico secondo le esigenze storiche di volta in volta emergenti.
Il più compiuto studio nomologico che attualmente è stato condotto in Italia sui beni comuni, si deve ad una parte della dottrina privatistica attenta alla realizzazione delle prescrizioni costituzionali, aderendo sin dagli anni ’70 alla confutazione del carattere meramente programmatico delle disposizioni della Carta costituzionale. Nel 2007 è stata istituita una apposita Commissione, i cui lavori risultano l’oggetto maggiormente accreditato ed organizzato ai fini dello studio dei beni comuni. Da tale Commissione è sorta la inascoltata proposta di uno schema di disegno di legge delega al Governo del giugno 2007, in cui si distingueva tra beni comuni, beni pubblici e beni privati, in cui si definivano i beni comuni come le cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. In tale proposta, i beni comuni sono stati suddivisi al loro interno in beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali e beni fruttiferi, con l’intento di superare l’attuale regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l’introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone pubbliche fondata sulla loro natura, e sulla loro funzione, in relazione agli artt. 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97, 117 della Costituzione. Sono state anche proposte forme di tutela giurisdizionale in difesa delle ragioni dei soggetti, pubblici e/o privati, che hanno una relazione qualificata rispetto ai beni comuni.
La posizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione risulta allo stato la seguente: <<Dalla applicazione diretta degli artt. 2, 9, e 42 Cost. si ricava il principio della tutela della personalità umana e del suo corretto svolgimento, nell’ambito dello Stato sociale, anche in relazione al “paesaggio”, con specifico riferimento non solo ai beni costituenti, per classificazione legislativa-codicistica, il demanio e il patrimonio oggetto della “proprietà” dello Stato, ma anche riguardo a quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione, risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività e che – per tale loro destinazione alla realizzazione dello Stato sociale – devono ritenersi “comuni”, prescindendo dal titolo di proprietà, risultando così recessivo l’aspetto demaniale a fronte di quello della funzionalità del bene rispetto ad interessi della collettività>> (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665). A prescindere da ogni definizione dottrinaria e pretoria, risulta da edificare la categoria composita di bene comune, che occorre coordinare con quella di bene collettivo, la quale ultima pone seri problemi di connessione con la figura delle proprietà collettive, storiche ed eventualmente contemporanee, o prospettabili in un futuro non troppo lontano in alcuni settori critici. Occorre rilevare che nel presente lavoro l’ottica politologica che definisce come comuni quei beni che non coincidono né con la proprietà privata né con la proprietà statuale ma che esprimono dei diritti inalienabili dei cittadini, invero, non viene integralmente sposata, poiché nel presente articolo si auspica una tecnicizzazione che renda la categoria dei beni comuni una categoria non aprioristicamente incompatibile coi beni che erano privati e che per mezzo dei meccanismi pubblicistici degli enti pubblici territoriali divengono beni comuni regolati, retti dal principio di legalità.
Nell’ottica del presente articolo, si considera da vicino anche la tematica della rinunziabilità della proprietà immobiliare, proprio in virtù dell’effetto peculiare di tale atto, ossia l’effetto di cui all’art. 827 cod. civ. di acquisizione statuale del patrimonio divenuto “vacante”. La dottrina è tornata a riflettere sulla tematica della rinunziabilità in questione in ragione della persistenza in seno al tessuto sociale delle strutturali criticità economiche. Gli studiosi si sono domandati se l’atto in questione abbia o meno natura negoziale; gli orientamenti maggioritari inquadrano la rinunzia abdicativa della proprietà di una resimmobiliare come un negozio unilaterale non recettizio, che non richiede l’accettazione né la conoscenza da parte di altri soggetti (ma su questo aspetto si era aperto uno specifico dibattito), e che deve avere la forma scritta ed essere soggetto a trascrizioneex art. 2643, n. 5 del codice civile. Alcuni studiosi hanno sostenuto la natura non negoziale dell’atto de quo poiché gli effetti specifici che esso produce non sono riconducibili all’elemento volontaristico del rinunziante, bensì soltanto alla legge: gli effetti si sintetizzano nel meccanismo di cui all’art. 827 cod. civ., e quindi nell’acquisizione del bene immobile da parte dello Stato. La dottrina ha poi chiarito che oltre alla proprietà cosiddetta esclusiva, la rinunzia abdicativa può avere ad oggetto anche la quota in comproprietà del soggetto rinunziante: in tal caso l’effetto è costituito dalla espansione, dall’accrescimento delle quote dei restanti comproprietari, poiché non può ritenersi praticamente ammissibile in tal caso una comunione ordinaria fra l’ente statuale e i rimanenti comunisti. Si è discusso abbastanza anche sulla diretta derivazione o meno dell’effetto accrescitivo anzidetto dall’atto rinunziativo: secondo un orientamento che ha trovato il proprio successo in seno a diversi studi ricostruttivi della tematica, l’effetto espansivo sarebbe soltanto mediatamente ed indirettamente riconducibile all’atto di rinunzia abdicativa, giacché sarebbe invece inquadrabile quale effetto conseguenzialmente connaturato alla conformazione strutturale e alla logica giuridica della proprietà in comunione ordinaria. A sostegno di tale ultima tesi è stato rilevato che la categoria più generale della rinunzia, a rigore, costituisce il presupposto soltanto della dismissione del diritto proprietario; la dismissione sarebbe poi diversa dalla estinzione, la quale ultima è soltanto eventuale. Vi sono infatti ipotesi in cui il diritto, a seguito di un atto di rinunzia, nella sua accezione più generale, non si estingue per la sussistenza di interessi di altri soggetti, ma questa osservazione rappresenta un nodo critico ancora irrisolto nel variegato dibattito della comunità scientifica in tema di dismissione proprietaria del privato. Vi è però chi al di là dei singoli problemi tecnici inerenti all’inquadramento e alle dinamiche concrete della rinunzia abdicativa della proprietà immobiliare, non condivide gli effetti di tale atto, per ragioni sociali di derivazione costituzionale; i nodi che vengono al pettine sono di natura eminentemente sistemica e ordinamentale. Altro problema irrisolto perché non affrontato è quello della rinunziabilità della proprietà di un bene immateriale disciplinato legalmente ed avente rilevanza socioeconomica: qui troverebbe molto spazio la discrezionalità tecnica del giudice in ragione dei casi di volta in volta sottoposti alla sua attenzione.





























