
«Ma nondimen, rimossa ogne menzogna,
tutta tua vision fa manifesta;
e lascia pur grattar dov’è la rogna»
(Paradiso XVII, vv.127-129)
Sedici canti prima di questo e sedici canti dopo: siamo nel canto centrale del Paradiso e nel terzo dei tre che hanno come protagonista Cacciaguida degli Elisei, una doppia coincidenza che, stando l’attenzione di Dante all’uso dei numeri, non può essere casuale.
Ed infatti è questo il momento della definitiva consacrazione della sua missione.
Già nel canto quindicesimo c’era stato un parallelismo tra la coppia Enea/Anchise e quella Dante/Cacciaguida. Qui, quel richiamo si fa esplicito: se Enea aveva potuto visitare l’oltretomba perché dai suoi discendenti sarebbe sorta Roma, Dante, con i suoi versi, dovrà contribuire alla riforma della Chiesa e dell’Impero. Per questa ragione, gli viene ufficialmente assegnato il compito di raccontare ciò che ha visto nei tre regni dell’oltretomba, in particolare in Inferno e Purgatorio: costi quel che costi.
Un suggerimento: non dobbiamo cadere nell’errore di leggere questi versi col senno di poi. Ora che la storia ha dato ragione al poeta fiorentino, ora che la sua vita si è infuturata (v.98) e la sua “Commedia” è stata battezzata come “Divina”, è facile concludere che Dante abbia fatto bene a non essere timido amico della verità (v.118). Ma è giusto non perdere di vista il contesto in cui questi versi sono stati pensati.
Chi scrive, è in esilio, con accuse infamanti, e, per scelta o costrizione, non rimetterà mai più piede nella sua Firenze: neppure da morto. Perché mai accetterà le condizioni umilianti, oggi le definiremmo un “patteggiamento”, che gli verranno prospettate per tornare a casa.
Nel 1315, i Guelfi Neri avevano offerto un’amnistia a chi si trovava in esilio. Eppure nell’Epistola XII, ad un amico, non si sa se personaggio reale o fittizio, che gli propone di cogliere l’opportunità di pagare una sanzione pecuniaria e passare una sola notte in prigione, pur di tornare libero cittadino nella sua città, il poeta risponde: «Se un’altra via prima o poi da voi o da altri verrà trovata, che non deroghi alla fama e all’onore di Dante, l’accetterò a passi non lenti; ma se per nessuna onorevole via s’entra a Firenze, a Firenze non entrerò mai». E con la sua solita spiazzante franchezza conclude: «E certamente non mi mancherà il pane».
Ecco, è questo il contesto del discorso di Cacciaguida, un annuncio “senza peli sulla lingua” del triste destino che i suoi concittadini riserveranno a Dante, una profezia post eventum (i fatti annunciati come futuri sono in realtà già accaduti nella sua vita), ben più esplicita delle vaghe allusioni di Farinata degli Uberti, Brunetto Latini e Oderisi da Gubbio.
Dante dovrà sperimentare quanto sa di sale il pane altrui, dovrà prima scendere (perché rifiutato) e poi di nuovo salire (per tornare a elemosinare ospitalità) le scale altrui, dovrà separarsi dai suoi stessi compagni di partito, in realtà una compagnia malvagia e scempia, e dovrà risolversi a vivere in solitudine, facendo parte per se stesso (vv.58-69).
Davanti alle sue comprensibili esitazioni, Cacciaguida esorta:
«Ma nondimen, rimossa ogne menzogna,
tutta tua vision fa manifesta;
e lascia pur grattar dov’è la rogna»
(Paradiso XVII, vv.127-129).
Ovvero, non basta che Dante resti tetragono ai colpi di sventura (v.24); la sua parola dovrà farsi vento che le più alte cime più percuote (v.133-4); Dante dovrà procacciarsi molti nemici, di quelli illustri e potenti, proprio nel momento in cui la sua vita, la sua famiglia, i suoi figli avranno più bisogno di soccorso, appoggio, protezione.
Una sorte avversa, che egli accetta a passi non lenti.
Certo, sarà anche accolto da mecenati, primo fra tutti Cangrande della Scala, sotto la cui ala troverà sostegno e sicurezza. A lui qui riserva un lungo panegirico e, come si legge nell’Epistola XIII, a lui sarà dedicata la terza cantica del Paradiso. Si direbbe: un atto più che dovuto, un omaggio quasi servile che non si addice alla fierezza del ghibellin fuggiasco.
Ma ci si provi a lasciare ogni cosa, a mettersi contro tutto e tutti, papi, signori e cardinali regnanti, e poi ditemi se quest’uomo non ha avuto coraggio, e se non sia stato capace di affrontare un cammino che è lo stesso che l’ha condotto fino a noi, qui ed oggi. E che, azzardo, continuerà ad aprirgli la strada del futuro.
Tucidide: «Il segreto della felicità è la libertà, e il segreto della libertà è il coraggio».
Gianni Rodari:
«È difficile fare
le cose difficili:
parlare al sordo
mostrare la rosa al cieco.
Bambini, imparate
a fare le cose difficili:
dare la mano al cieco,
cantare per il sordo,
liberare gli schiavi
che si credono liberi».
Serena Santorelli: «Qualcuno sceglie di vivere come può. Qualcun altro come deve. E poi c’è chi sceglie di vivere come crede… ma per quello ci vuole coraggio».



















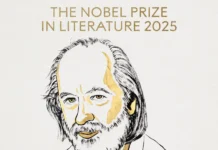










Dante è nato Dante. Di poche o di molte parole a secondo dell’interlocutore. Un carattere per niente incline al compromesso ben sapendo quello che viene a costare un termini di tranquillità e di un percorso di vita degno di essere vissuto. Mi è piaciuto il commento al canto XVII del Paradiso. Chiaro e non di poco conto.
Grazie!