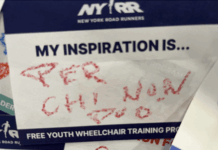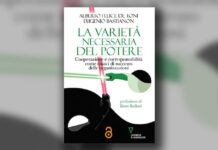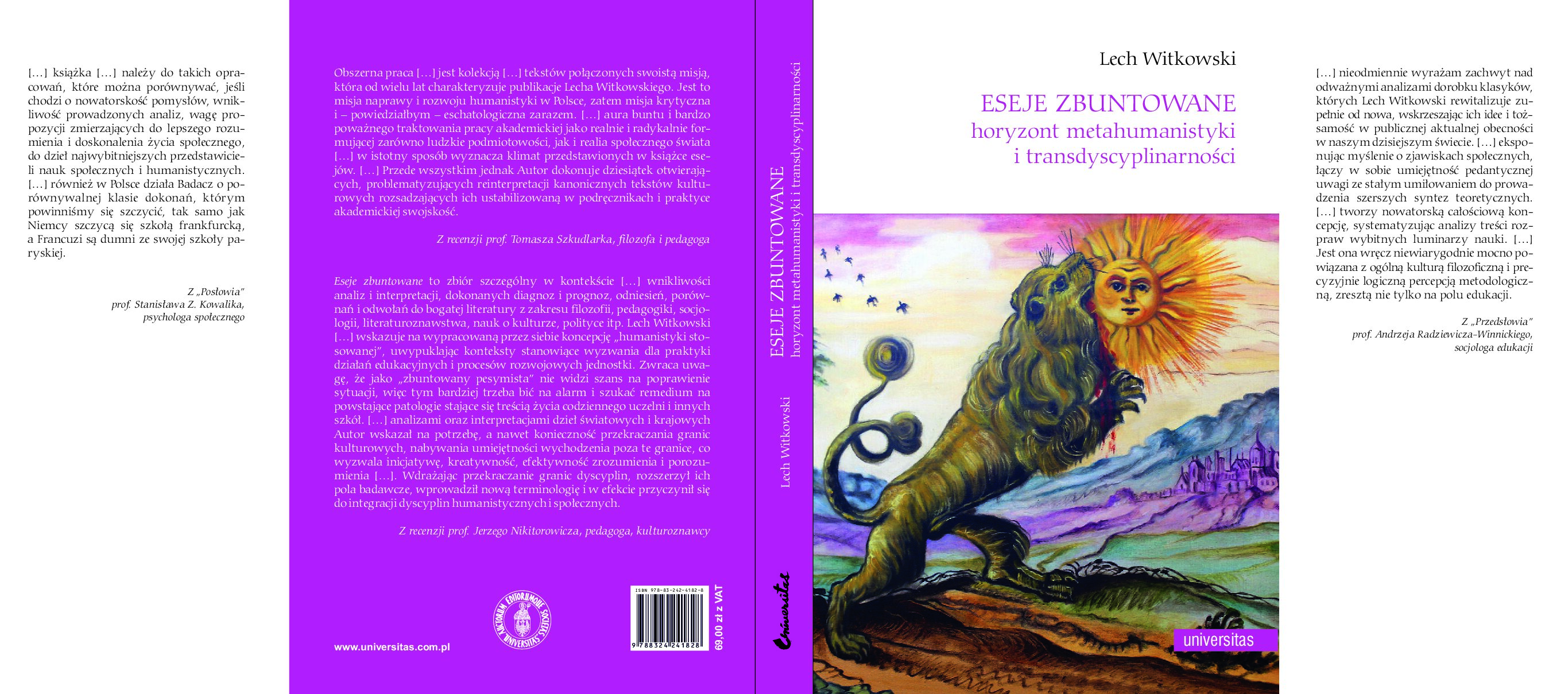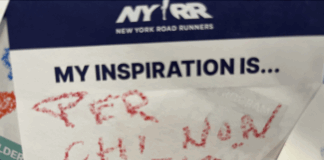Il contributo di Antonio Bergamo
Anche se può sembrare riduttivo approcciarsi verso delle figure di per sé poliedriche in base ad uno specifico interesse per ciò che hanno potuto avanzare in un determinato campo, può essere nello stesso tempo proficuo per valutarne l’originalità e coglierne l’attualità, specialmente poi se vengono affrontate alla luce dei contenuti veritativi portati in dote dalle singole scienze e da saperi come la filosofia e la teologia; poi ‘ben compresi’, come indicava a fare un secolo fa Pierre Teilhard de Chardin a proposito della teoria dell’evoluzione (Pierre Teilhard de Chardin, una figura sempre più vicina a noi, 26 giugno 2025), tali itinerari di pensiero, presi nel loro insieme, si stanno rivelando come degli indispensabili percorsi sempre più lanciati verso una ‘nuova alleanza’, nel senso già delineato nel secolo scorso dal Premio Nobel per la Chimica Ilya Prigogine, per essere all’altezza del nostro tempo, ‘tempo della complessità‘ per il suo pieno di sfide molte delle quali inedite e nel continuare a ‘generare nuove sfide’, come ha scritto recentemente Mauro Ceruti. Se le scienze per loro natura sono percorsi che dischiudono degli orizzonti di natura cognitiva proiettati verso il futuro, le altre costellazioni concettuali, come la filosofia, l’arte e la teologia, si portano addosso, certamente, il pesante e nello stesso tempo imprescindibile fardello del passato, ma rimettono con forza al centro dell’interesse la questione di natura sia cognitiva che esistenziale da dove si proviene, oltre a costituire un legame con ciò che siamo stati; poi, se ben coniugate con il non facile patrimonio scientifico per una serie di salutari decentrazioni messe in campo (Il ruolo trainante delle decentrazioni, 17 novembre 2022) e a sua volta faticosamente acquisito sul terreno storico, lanciano delle piste per affrontare l’altrettanto cruciale questione verso dove si vuole andare, decisiva per mettere in campo dei principi simbiotici tra l’umanità intera e la Terra, base per ‘la costruzione di un sistema complesso’, come ha scritto Jürgen Moltmann qualche anno fa in uno scritto dal titolo La svolta ecologica nell’ermeneutica biblica.
Ed è quello che ci viene proposto da Antonio Bergamo, grazie al confronto con María Zambrano, nel suo ultimo lavoro Claritas, il darsi della Luce in María Zambrano (Roma, Città Nuova Ed. 2025), dopo altri lavori dove si tracciano dei percorsi ermeneutici ispirati al pensiero di Emmanuel Lévinas e all’antropologia trinitaria grazie all’implicita valenza relazionale che la caratterizza; si è arrivati, tramite tale non comune via, a dare un volto alla complessità per il suo intrinseco continuare a generare ‘nuove sfide’ come la “complessità sociale del tempo”, ritenuta in Essere, tempo e Trinità(Roma, Città Nuova Ed. 2021) una volta “abitata” proprio nel senso di Simone Weil, una “sfida posta al pensiero di abbracciare la totalità”. E tutto questo è stato coltivato sulla scia di strategiche indicazioni prese da Edgar Morin e Romano Guardini (Romano Guardini cuore pensante della polarità, 29 ottobre 2020; Come ‘svegliarci’ grazie al fare nostri ‘i miei filosofi’ di Edgar Morin, 29 dicembre 2022); tali figure si sono impegnate a mettere in campo degli strumenti per ridare al pensiero una nuova forza trainante dopo averne denunciato la ‘mancanza’, già evidenziata da Paolo VI nella Populorum Progressio, con il conseguente pieno di riduzionismi di varia natura che hanno costellato la nostra storia.
L’abbinamento ermeneutico di complessità e di principi trinitari, nel senso avanzato da Klaus Hemmerle (Per una ragione agapica: il dono del Manifesto, 21 luglio 2022), e visti nella loro piena dimensione relazionale, ha permesso ad Antonio Bergamo di inserirsi appieno nella rifioritura di studi su María Zambrano, ‘voce che veniva da lontano’ o ‘voce dell’anima’, come recentemente è stata considerata come, ad esempio, da Massimo Cacciari; tale figura è stata interrogata in profondità come vero e proprio ‘cuore pensante ‘, nel senso di Etty Hillesum, per essere stata “una testimone delle lacerazioni della modernità e al contempo della decisività del sacro nella genesi del pensiero occidentale”. Si è così entrati nelle sue vene più nascoste per farne emergere un autentico “pensiero delle ‘viscere’” con l’obiettivo primario di andare al di là delle interpretazioni puramente esistenziali e sentimentali per cogliere “quel sapere dell’anima” o “ragioni dell’anima” ed “accedere a un diverso conoscere” col sottolineare il fatto, da pochi preso in considerazione, che María Zambrano abbia dato spazio alla stessa matematica “diffusamente presente nei suoi testi” e vederla “all’interna unità della physis” nel senso pitagorico; in tal senso sono stati interpretati alcuni testi della maturità come Chiari di bosco del 1977 con evidenziare il ruolo epistemico assegnato ad ogni forma di conoscenza che “è un’esperienza trasformativa nella misura in cui essa si rapporta al logos sommerso, logos del pathos, che lega e compagina il procedere del/nel reale”.
E l’intera interpretazione messa in campo da Antonio Bergamo si concentra sulla centrale idea di claritas, frutto di una particolare “strategia narrativa” che caratterizza l’intera avventura di pensiero della pensatrice spagnola e basata sulla “tensione aperta tra conoscente e conosciuto” che viene a situarsi “sulla frontiera tra luce ed ombra”; in tale luogo agisce il “sentire originario” del soggetto nel suo incontro/scontro col reale e l’altro col suo fungere “da ponte tra il precategoriale e il protocategoriale, illuminando i primi movimenti della relazione dell’uomo con il mondo” e diventare un percorso e “via d’accesso fondamentale alla comprensione della realtà e dell’esperienza umana”. La conoscenza, come Michel Serres nei suoi molteplici lavori ha evidenziato col ricorrere alla metafora della dea romana Vesta come dea del chiaroscuro tipica del focolare, è un continuo gioco tra luce ed ombra, dove però si generano nuovi orizzonti, e tra quello che si trova sotto terra e quello che emerge come ad esempio in una tomba dove si nota solo il nome col concentrarsi su di esso; e molta riflessione epistemologica, a partire da quella greca, ha preso in esame solo quello che emerge col mettere da parte il nascosto, magari più autentico, il contenuto reale, che in termini zambraniani ha bisogno di un pathos e delle ragioni del cuore per rivelarsi come autentico logos. E la claritas, frutto delle ragioni del ‘cuore’, “metafora che sembra attraversare tutto l’ampio spettro della riflessione di María Zambrano”, è il momento in cui esso ‘si abbandona, si concede. Si raccoglie’, come è scritto in Chiari di bosco, col diventare “sia il bagliore dell’istante, che la latenza della luce” oltre ad inoltrarci nell’”eccesso di essere con il virtuale”, processo che poi dischiude “il tra di un incontro” con il mondo e con gli altri.
Così, un testo strategico come Chiari di bosco si rivela un percorso intenso sul piano propriamente conoscitivo e viene a delineare “un pensiero ‘dalla’ claritas” dove per Antonio Bergamo “i chiari indicano un metodo, un processo e una postura: un metodo epistemologico esistenziale”, tesi a cogliere “il reale nella sua viva tensionalità”, a gettare le basi di “un modo d’essere e di pensare”, a dare visibilità concreta alla “luce che emerge dalle pieghe del reale’” e dalla ‘rugosità del reale’ a dirla con Simone Weil, un altro ‘cuore pensante’ del ‘900 distintosi nel gettare le basi di un pensiero delle radici (La complessità: un pensiero delle radici sulla scia di Simone Weil, 13 giugno 2024); nello stesso tempo, i chiaripermettono di superare la visione strettamente empiristica dei dati conoscitivi in quanto frutto di un processo dove “soggetto e oggetto sono intrecciati” e sensi ed intelletto sono coinvolti in un necessario processo di mediazione, senza il quale, nel riportare una importante indicazione di Stephen Toulmin, si entra inevitabilmente in ‘una curiosa atmosfera di irrealtà che circonda i risultati raggiunti’. I chiari sono espressione del sano incontro del soggetto con l’oggetto e quando questo avviene si tramuta in ‘progetto’, come ha scritto Gaston Bachelard in Le nouvel esprit scientifique del 1934 nell’invitare a prendere congedo dalle visioni empiristiche della conoscenza, che poi diventano spesso l’anticamera sul piano umano di posizioni di natura assolutista; e frutto della tensione del “soggetto verso l’esterno” portano nel loro grembo un dono quasi agapico, nel senso giovanneo del termine e aspetto che permea tale lavoro di Antonio Bergamo, quello di un nuovo progetto che nasce “dall’interno” e che fa prendere coscienza in primis dei limiti delle stesse conoscenze prodotte con offrire dei “metodi che esplorino i vincoli e i percorsi ammissibili nel reale” sino a creare dei sempre più necessari “spazi di resistenza ai riduzionismi della realtà”.
E tale vero e proprio volto della complessità, che emerge da questa “singolare forma di epistemologia esistenziale” vista presente in Chiari di bosco sino a costituire un nuovo capitolo della riflessione filosofica sulla scienza del ‘900, si arricchisce nel pensiero di María Zambrano di un altro contributo, quello del “darsi della ragione poetica” o dell’“aurora della ragione poetica”; si intende con essa l’espressione stessa del ‘sapere dell’anima’ all’interno della problematica e “grande questione” di “cosa faccia di un essere umano una persona e su cosa possa una persona nel suo sentire”, dove vengono a giocare un rilevante ruolo “emozioni, passioni e sentimenti” e la metafora stessa per la capacità di cogliere cose che la ragione non riesce a fare, ma disponibili ad essere ‘captate’ con spirito diverso, come è scritto in Verso un sapere dell’anima, anche perché “nella metafora pensiero e vita si incontrano” e si arriva a dare il giusto spazio all’altrimenti. E per evitare di essere “confinati nell’esilio dell’irrazionale”, Antonio Bergamo è dell’avviso di insistere sul “legame che li unisce alla conoscenza” e si chiede, andando sempre in profondità nel pensiero di María Zambrano, se vi sia “un contenuto e una forma di conoscenza” nell’”affectio umana”, dove la ragione poetica con la sua forza “vivificante e creativa” “agisce da “tensore’ di un ‘quadro“ nell’organizzare ed integrare “elementi diversi come intuizioni, emozioni e percezioni estetiche”.
Si rivela così interessante, per comprendere meglio sia la dimensione epistemica che la “postura antropologica” del pensiero di María Zambrano, il confronto messo in campo da Antonio Bergamo con alcuni risultati della psicologia delle emozioni ed in particolar modo con la loro visione costruttivistica e neurocostruttivistica presente nei lavori di Lisa Feldman Barrett, che ha fatto tesoro dei fondamentali lavori in neurobiologia di Gerald Edelman e di Antonio Damasio; l’emozione, frutto delle infinite interconnessioni del cervello, viene costruita grazie alle esperienze e si presenta come una vera e propria ‘categoria’ col dare spazio a delle ‘occorrenze’ dove si assiste al “farsi della persona nella relazione” grazie all’entrata in gioco della “nozione di affetto” che, collaborando con la razionalità, ci “si proietta in avanti, contribuendo a costruire la realtà nella quale viviamo”. Ciò che emerge da questi risultati è, pertanto, la “chiarezza cognitiva ed emotiva”, cioè “la capacità di pensare in modo chiaro e coerente, certo, ma anche in “contesto, a partire dal costitutivo legame con la natura e con gli altri” che poi porta alla formazione della singolarità di ogni individuo; e dall’approccio di Lisa Feldman Barrett emerge un volto della complessità, intesa come ‘metrica’ grazie al fatto che nel cervello viene a configurarsi un enorme ‘repertorio di esperienze” rendendolo un ‘sistema a elevata complessità’, come si riporta in Come sono fatte le emozioni, col criticare le posizioni essenzialiste in campo psicologico. Per questo Antonio Bergamo lo evidenzia come “una cifra della complessità” basata su “un conoscere cognitivo-affettivo integrale”, aspetto che gli ha permesso di “esplorare la proposta di María Zambrano”, di analizzarne il fondamentale concetto di claritas, nel “fungere da ponte tra cognizione ed emozione”, nel “tenere desta l’attenzione alla pluralità dei livelli coinvolti” e nel fare dei processi conoscitivi un insieme di “interazioni dinamiche” che arricchiscono il patrimonio di ognuno di noi.
E tale postura antropologica di fondo o “domanda antropologica fondamentale”, che ogni sano percorso di natura cognitiva e di epistemologia esistenziale porta con sé specialmente se poi è potenziato dalla ‘cifra della complessità’, è il lascito più consistente visto presente da Antonio Bergamo nell’intero percorso di María Zambrano in quanto porta alla domanda più radicale ‘Cosa può un io quando si dona a un tu?’, questione che i Maestri del pensiero complesso hanno messo sul tappeto nel chiedersi e nel farci chiedere ‘su cosa io possa fare per te?’; nella “sua filosofia della claritas” ha preso, infatti, “forma e voce” in modo integrale l’essere umano “in cui interiorità ed esteriorità sono sovrabbracciate nel logos che scorre nelle viscere”, dove scorre impetuoso quel ‘fuoco della verità’, a dirla con Pavel Florenskij, che si manifesta e viene alla “Luce” e che nessuna impalcatura è in grado di contenere in recinti aprioristicamente costruiti. E nelle pagine di María Zambrano, così come viene evidenziato in Claritas, pulsa continuamente la logica cognitivo-esistenziale dove ogni forma di conoscenza, appunto perché attraversata dal ‘logos che scorre nelle vene’, porta ad “un’intima solidarietà ontologica” che va chiarita e coltivata in quanto “è al tempo stesso contemplativa e generativa, radicata nell’intuizione e nell’atto creativo del soggetto nel suo essere accompagnato nella vita radicale e sorgiva”. E si deve essere grati ad Antonio Bergamo per essere penetrato profondamente in un’anima e nello stesso tempo per avercela consegnata come un volto incarnato della complessità, di ‘abitarla’ come “il ‘bosco’ del reale e di cogliere in esso, nelle sue molteplici esperienze, il darsi della Luce come comunione”.