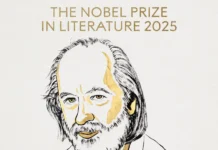«Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
consiros vei la passada folor,
e vei jausen lo joi qu’esper, denan»
(Purgatorio XXVI, 142-144)
Il protagonista indiscusso del Canto è Guido Guinizelli, che Dante definisce “padre suo e degli altri poeti migliori di lui” (Purgatorio XXVI, vv.98-99). L’intervento di Guido si articola in tre icone successive: lo stupore per il fatto che Dante visiti il Purgatorio in carne e ossa, il chiarimento circa la pena dei lussuriosi, la lunga parentesi dedicata a celebrare la poesia d’amore secondo una sorta di genealogia che da Arnaut Daniel va a Guinizelli medesimo e da lui ai poeti dello Stilnovo.
Non mi attarderò su questa materia, invitando il gentile e curioso lettore a confrontarsi direttamente coi versi di Dante.
Mi limiterò a due considerazioni complementari.
La prima prende spunto dal “debole” che Dante prova per i lussuriosi. La seconda si lascerà contaminare dalle parole, in lingua d’oc, pronunciate dal Daniel in chiusura del canto.
Quanto all’occhio di riguardo di Dante per chi è vittima di lussuria, osservo che nell’Inferno i lussuriosi sono i primi dannati che incontriamo, quindi quelli più lontani da Lucifero, cioè quelli, nello schema dantesco, col peccato meno grave. Di più, abbiamo visto come la seconda metà del canto V dell’Inferno sia luogo di pietà e di preghiera, di parole gentili, di compassione: è il canto di Paolo e Francesca, ma anche il canto di Dante. Viceversa, qui in Purgatorio, i lussuriosi sono gli ultimi ad essere incrociati, dunque i più vicini alla vetta del Purgatorio, vale a dire, i più vicini a vedere Dio. Basterebbe questo per far pensare ad una sorta di “occhio di riguardo” che, nella morale dantesca, tende a mostrare comprensione per chi è vittima d’amore. Se poi si aggiunge che gli ultimi due penitenti che sentiamo parlare sono papà Guinizelli e nonno Arnaut, il cerchio si chiude: ed è un cerchio che si compie nel dialogo d’amore che, per quanto peccaminoso, conduce al Cielo. Di qui in poi, saranno solo i beati a prendere parola…
Come accennato, questa prima considerazione vuole essere complementare con quanto dichiara Arnaut Daniel:
«Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;
consiros vei la passada folor,
e vei jausen lo joi qu’esper, denan»
(Purgatorio XXVI, 142-144)
In traduzione: Io sono Arnaut che piango e avanzo cantando; medito contrito la passata follia e gioioso contemplo la gioia che spero davanti a me.
Follia (folor): la parola che mi ha fulminato. Non solo perché, mio malgrado, più di vent’anni fa ho pubblicato un volume che provava a indagare la ragionevole follia d’amore in Simone Weil.
Fulminato, perché follia è parola chiave in quanti hanno provato a vedere oltre il visibile, pagando a caro prezzo la libertà di uscire dagli schemi.
Penso ai folli di Shakespeare e di Velázquez, tanto per citare ancora la Weil, penso all’Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, penso alla follia della Croce di tale Gesù Cristo così come ci è raccontato da san Paolo nella sua prima lettera ai Corinzi.
Penso a ognuno di noi, quando è disposto a perdere tutto per non perdere niente che sia bello, buono, unico, vero.
E penso di essere un tantino folle.
Pietà di me, o tu che leggi!
Edgar Allan Poe: «Divenni pazzo con lunghi intervalli di orribile sanità mentale».
Carl Jung: «Mostratemi un uomo sano di mente e lo curerò per voi».
Samuel Beckett: «Nasciamo tutti pazzi. Alcuni lo restano».