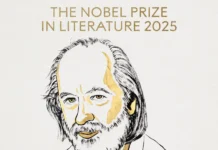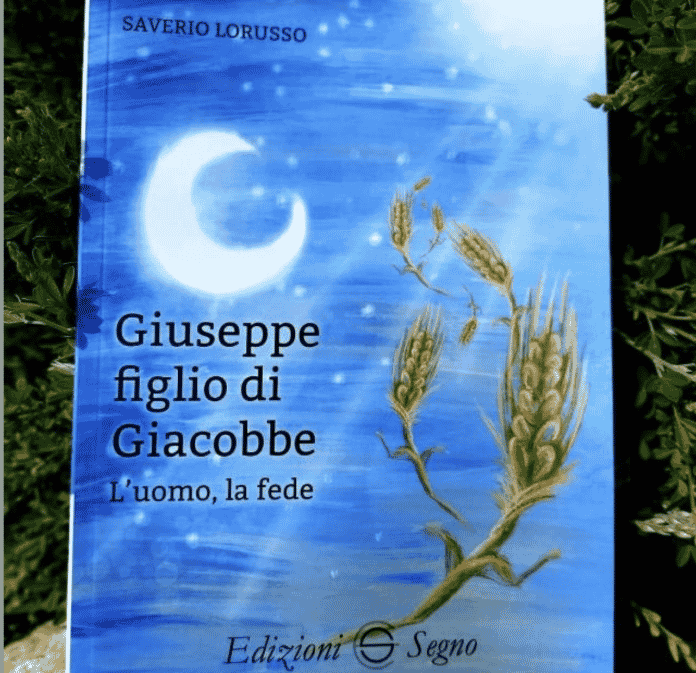
La testimonianza dell’esistenza di Dio nelle nostre vite
In un processo frontale e normativo, in cui è possibile dire di Dio parlando dell’essere umano, risulta difficile coltivare la pietas verso il Signore e nei confronti dei nostri simili. A questo proposito, Saverio Lorusso, nel suo libro “Giuseppe figlio di Giacobbe, l’uomo e la fede”, pone l’attenzione sulla comunicazione rivelatrice dell’Altissimo nella comprensione identitaria del singolo individuo
Nel tuo libro “Giuseppe figlio di Giacobbe” chi è l’uomo Giuseppe e quale fede lo muove?
Il Giuseppe che si incontra nel mio libro è un giovane che è nell’età della vita compresa fra l’adolescenza e la maturità, detto “bello di forma e attraente di aspetto” (Gn.39,6), caratteristiche che aveva ereditato dalla dolce e bella Rachele, sua madre.
La personalità del giovane protagonista si evince dai testi biblici, egli infatti appare come un giovane uomo fedele, maturo, responsabile, saggio e colmo di buon senso, rispettoso verso il padre Giacobbe e stimato da quest’ultimo, dal quale apprende la saggezza, la fede, la morale e i costumi. Inoltre egli si mantiene lontano dal male, retto moralmente, manifesta sentimenti di premura e di attenzione verso i suoi fratelli, ma nello stesso tempo per la sua giovane età presenta tratti di ingenuità, appare marcatamente sentimentale ed eccessivamente sincero, il tutto accompagnato da una seria incapacità a dominare la lingua.
Egli è anche l’uomo dei sogni, dei desideri, della spiritualità del desiderio, insomma un visionario che guarda più in là e prima degli altri.
Questo in linea generale il profilo psicologico, morale e umano del giovane figlio di Giacobbe, nelle sue qualità e nelle sue deficienze.
Giuseppe, inoltre, in questa complessa vicenda, appare come una figura affascinante, un ragazzo esemplare e virtuoso che matura nel suo percorso esistenziale e nel suo cammino di fede una estrema fiducia in Dio, nel Dio di suo padre, nel Dio di Abramo.
La fede di quest’uomo nasce, dapprima, da una sincera e profonda relazione con il padre Giacobbe, di cui si fa uditore preferenziale e da questo rapporto singolare e privilegiato scaturisce il suo essere pontefice dell’amore del padre verso i suoi fratelli, il suo sì incondizionato all’Amore, il suo diventare servitore della pace della famiglia, il suo essere per gli altri nella scomodità, nella difficoltà e nel pericolo, la sua vocazione provata e il suo amore tradito da coloro che cercava di servire, appunto i suoi fratelli.
La fede di Giuseppe è un dono ricevuto dall’ascolto della Parola che gli donerà il padre Giacobbe e che in lui si farà compito da realizzare attraverso un luogo e faticoso percorso umano e spirituale.
Giuseppe resta una figura molto attuale che va riscoperta, la cui vicenda posta allo specchio con le nostre singole esistenze, penso possa essere rivelatrice di noi stessi, rivelatrice di un sé non ancora percepito e compreso in un tale senso.
I fatti e le parole che vengono annunciati e conseguentemente ascoltati, nella storia del giovane ebreo tradito e venduto dai fratelli, se correttamente compresi, potrebbero diventare chiavi interpretative delle esperienze di ogni singolo uomo e quest’ultimo potrebbe trovare nelle Sacre Parole il suo più autentico e profondo orizzonte di significato.
Insomma, credo valga la pena di leggere il libro “Giuseppe figlio di Giacobbe, l’uomo e la fede”, in quanto questa vicenda, così come io la interpreto nella mia opera potrebbe piacevolmante sorprendere il lettore e inoltrarlo in comprensioni inedite del sé, del noi e di Dio.
Cosa si intende per “antropologia teologica”?
Il significato etimologico della parola “antropologia” deriva dal greco e il lemma si compone del prefisso àthropos, appunto uomo, e il suffisso lògos, cioè pensiero…parola…discorso, cioè ragionamento-discorso sull’uomo, tecnicamente scienza che si occupa della natura umana.
L’antropologia, in generale, si chiede “chi è l’uomo” dal punto di vista sociale, culturale, naturale, politico, psicologico, ecc…, l’antropologia filosofica, poi, invita a riflettere su “chi è l’uomo nella sua ricerca e domanda di senso e di significato”.
L’antropologia teologica, infine, si chiede “chi è l’uomo per Dio” nel suo più grande orizzonte semantico, l’uomo così come Dio lo ha pensato e voluto.
Nella prospettiva dell’antropologia teologica, l’identità umana, inteso come singolo individuo, si poggia su quello che Dio rivela al singolo uomo di se stesso.
Quindi, l’antropologia teologica non è solo una conoscenza incentrata sulla riflessione su Dio, ma una gnosi sull’uomo frutto dell’iniziativa di Dio, appunto parte della “Rivelazione”. Insomma, Dio sceglie di venire incontro all’uomo e di dirgli da dove viene, chi è, qual è il suo compito nel mondo, in che modo può realizzarsi pienamente, dove è diretto, qual è il suo fine ultimo e quali mezzi sono necessari per raggiungerlo.
Nella parte del testo Veterotestamentario che riguarda la vicenda di Giuseppe e della sua famiglia, Dio sembra assente, non assistiamo a interventi diretti di Dio, né a visioni, né a rivelazioni, né a profezie, sembra che gli uomini siano gli unici protagonisti della storia eppure Dio opera e attraverso la fede si scopre la Sua Presenza. Come interpretare questo fatto?
La parola ebraica “midbar” significa “deserto…silenzio…assenza…nascondimento” ed ha la stessa radice della parola “dabar”, ovvero “parola, intesa come evento della rivelazione divina”.
Dunque il concetto del parlare o del tacere di Dio diventano sinonimo di una unica per quanto diversa rivelazione di Dio.
Precisato questo fatto, però, io porrei una riflessione sul cuore umano. Infatti secondo la spiritualità cristiana orientale il credente deve fare “attenzione al cuore”.
Questa attenzione consiste nell’essere attenti a sé stessi per essere attenti a Dio.
Così, l’uomo che abbandona progressivamente il peccato e si converte costantemente a Dio, sviluppa pian piano una “connaturalità” con il mondo spirituale.
Fare attenzione a questa connaturalità e alla sua voce, per la spiritualità cristiana orientale, vuol dire percepire i misteri divini quali essi sono in noi, così come entrano nella nostra vita.
Secondo il teologo Tomas Spidlik il cuore, così come sopra ho spiegato e inteso, è il luogo in cui la trascendenza divina e l’immanenza umana si incontrano ed entrano in una dialettica capace di scambiarsi le prerogative loro proprie.
Così compreso, dice T. Spidlik, “il cuore diventa una fonte di rivelazione”.
Ecco che intendendo in questo modo l’apparente assenza di Dio nella storia biblica del giovane Giuseppe e della sua famiglia si trova una possibile chiave ermeneutica.
Infatti Dio non parla, ma si rivela al cuore credente ed in cammino di Giuseppe ed egli rimanendo fedele a se stesso e alla voce divina che intende nel suo cuore mediante la fede interpreta le proprie vicissitudini e quelle della sua famiglia divenendo il salvatore dei suoi consanguinei e dell’intero popolo egiziano, per questo il testo sacro dice “il Signore fu con Giuseppe”, fu in quest’uomo mediante la sua fede.
Nell’ultimo libro della Genesi, “Bereshit”, ci si focalizza su Giacobbe e sull’intera famiglia di Giuseppe. In maniera quasi anacronistica, si può concludere che, tutt’oggi, le radici da cui proveniamo influenzano le nostre scelte?
Penso basti guardare alla nostra splendida penisola, alle nostre città, alle nostre chiese, alle nostre piazze, alle nostre opere d’arte e a tutta la cultura prodotta dai nostri connazionali nei secoli, per comprendere quanto la cultura ebraico-cristiana abbia influenzato i nostri modi di pensare, vivere, costruire, creare ed elaborare l’esistere umano in tutta la sua poliedricità.
Bisogna considerare che tutti i grandi poeti, scrittori e artisti europei del passato, remoto e recente, contavano nel loro percorso di vita almeno un viaggio nel Bel Paese, come una sorta di iniziazione spirituale, culturale ed artistica, da cui trovare ispirazione e visione nel proprio processo creativo.
Oggi, però, nel periodo post-moderno, ormai praticamente scristianizzato, dove il singolo è isolato nel circo mass-mediatico e tecnologico-digitale in una sorta di isolamento volontario, privo della consapevolezza delle proprie radici umane, culturali e spirituali, vedo difficile e praticamente inverosimile una vera e propria influenza del pensiero cristiano sul singolo e sull’intera società odierna.
Questo fatto, però, apre il campo ad una visione del presente carica di impegno atto a diffondere nuovamente il pensiero e l’esistenza cristiana in un lavoro da fare, non sulle masse, bensì sulle singole esistenze, mediante la trasmissione della fede da cuore a cuore, da vita a vita.
Tralasciando pericopi ed ermeneutica, quale messaggio ci testimonia e tramanda il kerigma cristiano contenuto nei Testi Sacri?
Risponderò a questa domanda utilizzando il pensiero che il filosofo Kierkegaard esprime nella sua opera “Briciole di filosofia e postilla non scientifica”, il quale scrive: «Tutta la mia attività letteraria si rapporta al Cristianesimo, al problema di diventare cristiani (…) contro l’illusione che “tutti sono cristiani”».
Il filosofo per smascherare questo fraintendimento sottolinea che la verità cristiana non è tanto o solamente “dottrina”, quanto essenzialmente una “comunicazione di esistenza” (kerigma) ossia è verità sull’uomo quando in lui diventa “esistenza”, cioè testimonianza di vita.
Egli sostiene che il cristianesimo si muove in una dinamica vitale precisa: annuncio del Vangelo, mediante parole e opere, appunto il kerigma, l’ascolto e l’accoglienza, poi, di tale annuncio porta all’esame della vita e alla coscienza del peccato del singolo, il quale nel Messia Gesù di Nazareth trova la propria rinascita spirituale ed esistenziale mediante l’imitazione del Modello Cristico.
In parole povere quando il Vangelo accolto diventa esistenza nel singolo, prima, e nella comunità, dopo, allora il cristiano può essere definito tale e l’insieme dei singoli diviene Chiesa, nella sua eccezione più vera ed autentica.
Il filosofo danese continua dicendo che il cristianesimo è tale quando diviene portatore del paradosso, infatti il Cristo, Uomo-Dio è scandalo per le categorie della ragione e la sua resurrezione è stoltezza per il mondo. Quindi, egli conclude scrivendo: «Non è la dottrina che deve essere revisionata (…) sono le esistenze che si devono revisionare», a partire dal kerigma, dall’accoglienza dell’annuncio del Cristo morto e risorto per i nostri peccati che diviene generatore di vita nuova da compiersi nell’oggi dei singoli divenienti credenti.