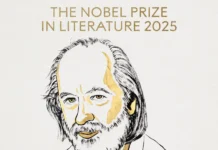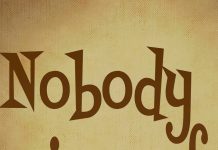«Non ti pagano per il lavoro, ti pagano per l’umiliazione»
(Sergio Cordero)
In quel laboratorio del CNR si lavorava sodo, Ginevra lo sapeva da quando aveva soli 26 anni e da Reggio Calabria, dove viveva e si era laureata, l’avevano chiamata a Bari, per iniziare il suo percorso. Allora non poteva certo sapere che quello sarebbe stato solo l’inizio: Bari divenne Sassari, per esempio, dove Sassari fu il materializzarsi di un laboratorio nuovo di zecca, che lei, ormai piena di encomi, doveva addirittura dirigere. Un’esperienza apparentemente spaventosa, più grande li lei, che in realtà era molto più grande di qualsiasi novità: possedeva l’arte magica di chi vale, lo sa, ma non ne fa né vanto, né pregio. Chi prende il proprio valore e lo mette a disposizione del proprio “mercato”: presto Sassari diventò Ginevra, la città svizzera che portava il suo nome e rappresentava il sogno, pressoché inarrivabile, di qualsiasi ricercatore volesse vedersi riconoscere un merito. Lì avrebbe proseguito le sue ricerche non solo dirigendo il laboratorio dell’ospedale, ma anche assumendo il nuovo ruolo di docente universitaria alla facoltà di biologia.
Una carriera segnata, appariva; una carriera in ascesa per una persona valida. Durò qualche anno, il tempo necessario per imparare che il merito, in questo mondo, non può davvero avere vita facile per le persone che, come Ginevra, valevano sì nel loro ambito, ma valevano anche per tutto il resto. La precisione maniacale, l’indomabile istinto di spendersi per i diritti di chi non conosce i propri diritti, l’incapacità di sopportare il sopruso, la maestria nel trovare sempre una spiegazione alle cose smontando pezzo pezzo i cumuli di cattiva fede dei più grandi in ruolo, sono caratteristiche che al sistema non piacciono. E il sistema, si sa, appena vuole, può: schiaccia. Lento ed inesorabile, calpesta, sminuzza, trita, distrugge.
Non troppo tardi Ginevra si trovò a fare i conti con qualcosa che era incapace di decifrare: un’intelligenza sopraffina che non conosceva corruzione, aveva urtato contro la macchina del clientelismo e prima di accettare che tutto questo esistesse davvero ovunque ed in qualunque ambiente, dovette lasciare che il meccanismo lento e subdolo la sedesse prima, inginocchiasse dopo, quasi uccidesse alla fine.
Cosa avevano usato? Il potere ipocrita dell’ umiliazione, quella reazione del nostro cervello che è di gran lunga più forte e deleteria di qualsiasi altra. L’umiliazione, infatti, scatena un’attività cerebrale rapidissima e intensa più dell’allegria, più negativa dell’ira e, come non bastasse, attiva aree associate al dolore. Seppure gli elogi risveglino gioia, il sentimento dell’umiliazione è di gran lunga più profondo e ciò che c’è di davvero inquietante è che nemmeno la rabbia regge il confronto.
Ginevra lo imparò benissimo e continuò per un lunghissimo tempo a subire le ingiustizie di un sistema che voleva farle pagare lo scotto che paga chiunque possieda una caratteristica: essere arrivato in alto con le sole proprie forze, dal basso, a suon di sacrifici e senza avere debiti di “Grazie” verso nessuno. Era arrivata troppo in alto però: e quando così in cima giunge qualcuno che non si lascia appiattire, né zittire e non è ricattabile poiché non ha mai messo debiti, allora deve essere punito, perché la macchina lurida del potere non accetta che la sua maestà venga lesa da qualcuno con il brutto vizio dell’onestà. Ma brutto davvero, al punto da meritare qualcosa di molto simile alla cremazione.
Con Ginevra mi fermo qui, perché a furor di popolo, una storia che inizia così dovrebbe avere un lieto fine: il bene dovrebbe sconfiggere il male, Ginevra dovrebbe fare leva su tutta la forza della sua proverbiale lealtà e dimostrare ai suoi carnefici che chi di umiliazione ferisce, di umiliazione perisce. Il punto è che tutto questo, specie in narrazione, potrebbe essere scontato. Io, invece, ho un altro pensiero adesso: quello che Ginevra ha passato prima di qualsiasi epilogo, il che ha ben poco a che vedere con l’autostima e le sue sorelle.
Si tratta della soddisfazione inaudita che gli uomini di potere, di qualsiasi potere, provano nel mettere alla gogna i propri simili appena quelli fanno semplicemente il loro dovere e reclamano i loro diritti; si tratta di credere che l’uomo sia buono in nuce e possa tornare alla sua bontà anche dopo essersi lasciato corrompere; si tratta di pensare ai cadaveri che nel frattempo ha lasciato sul suo cammino.
Ebbene no, non tutti gli uomini umiliati si rialzano, tocca fare pace con questa realtà: alcuni sì, rinascono più forti dalle proprie ceneri, ma non è così sempre. E questo non basta? Bisogna necessariamente continuare ad educare al servilismo per garantire la sopravvivenza di tutti? E quelli che si incazzano per questo, allora, li ammazziamo? Sono scomodi e li facciamo fuori?
Attenzione, perché anche chi si incazza soffre, anche chi si incazza nutre dolore, anche chi si incazza può mal sopportare le piaghe e non tutti quelli che si incazzano hanno la forza divina di Gesù Cristo.
Attenzione alla violenza, attenzione agli abusi, attenzione alle prevaricazioni, attenzione alle angherie, attenzione alle sopraffazioni.
Attenzione, attenzione a degradare l’intelletto di un altro essere umano: potrebbe rimanerne irrimediabilmente segnato e, con quei segni, mettersi poi ad insegnare quella che addirittura Gorbaciov definì “ecologia dell’anima”, qualcosa che a chiunque agisca umiliando il prossimo, non può in alcun modo piacere.
E non fa differenza se colui che umilia è un padre, un dottore, un ricercatore, uno scienziato, un autista, un militare, un prete, uomo o donna. Il comune denominatore per un certo genere di persone non cambia, uguale per tutti: schifo.