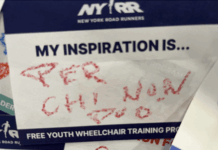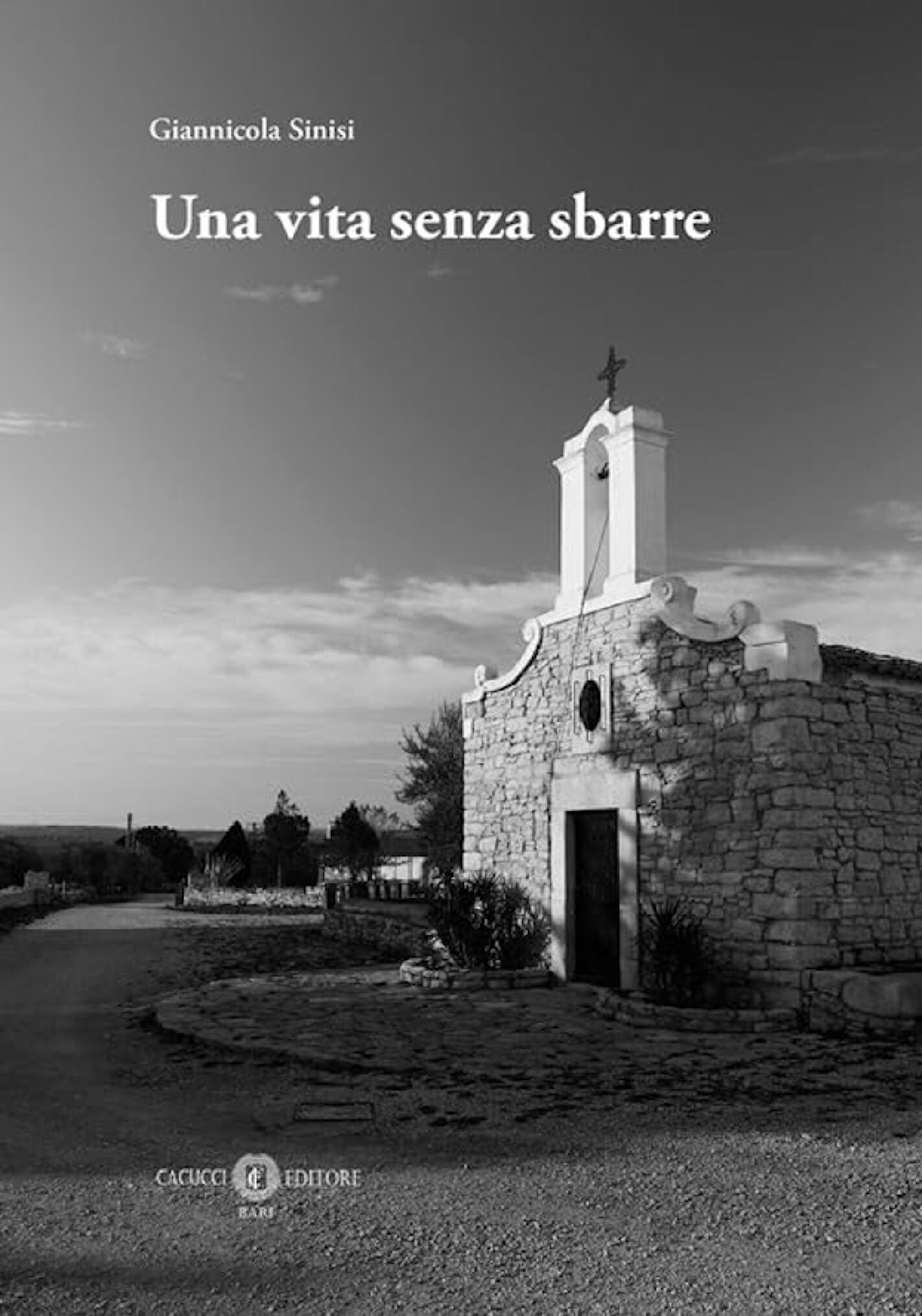A proposito de “La fiducia in Dio”
Non c’è bisogno di firmare alcuna capitolazione se da una parte si pensa a ravvedersi e dall’altra no. Ogni situazione oggettiva va determinata secondo la sua essenza. Aggiungere cornici superflue, magari di neve (Grazia Deledda), come tali, si scioglierebbero al sole. Laddove c’è un costrutto (…E perché fosse qual era in costrutto… Dante A. XII Paradiso), è proprio da lì che parte la “missione”, e ne resta il solido riferimento. (Bagnoregio, francescano, è colui che viene incaricato di parlare ed elogiare san Domenico, per poi passare ad affrontare il tema morale dell’Ordine francescano, in fase degenerativo).
La linearità la si deve notare e dev’essere sempre evidente, sia che faccia parte di un discorso, di uno scritto o di un qualsiasi altro componente con cui l’uomo voglia esprimere un concetto, erigere una struttura o raggiungere un fine. La coordinazione concettuale, nel caso di un discorso, non va alienata per dar spazio a fantasiose immagini che, col tema affrontato, non hanno nessuna attinenza. Arzigogolare significherebbe: averne perso il filo…
Certo che con la bravura uno può benissimo confrontarsi con diversi argomenti, concettualmente concordanti al tema aperto.
La mia mente ricorre a Giuseppe Giusti, poeta satiro della politica italiana. Ma il Giusti, in un momento di sofferenza amorosa, scrive dei bellissimi versi “La fiducia in Dio”. Versi che nulla hanno a che vedere con la satira. Ed è qui che il Poeta affronta due temi e lo fa con indescrivibile, mirabile destrezza: una con sorprendente conoscenza politica e l’altra con una forma di spiritualità insita e che lui fa emergere attraverso la poesia. La statua è una “Pietà riproposta” … dal Bartolini e dalla quale il Poeta, mirando la scultura, descrive in versi la fanciulla rappresentata. Questa è inginocchiata, estasiata, rapita in Dio… (In Quei che volentier perdona). Lorenzo Bartolini, allievo del Canova, stava ultimando l’opera che ora è conservata nel Museo Poldi Pezzoli, di Milano. Sia il sonetto sia la statua descrivono alla perfezione lo stato d’animo del soggetto, la fanciulla inginocchiata. Sia lo scolpito sia la descrizione in versi dello stesso, mettono sullo stesso piano: una brillante coerenza, fattuale-descrittiva.
È così che, il cimentarsi in un determinato lavoro, sempre con dovuta umiltà e rispetto per chi ne sa di più, non significa invadere il campo del vicino ma solamente osare, impegnarsi a fare cultura, ad emanciparsi a spese proprie, fare esperienza insomma. Farlo “Soavemente”, alla pari della fanciulla scolpita che si abbandona, rilassandosi sulle ginocchia e in Dio. Certo lo fa in un momento di trasporto sublime, di fede. Come ha fatto Giuseppe Giusti coi suoi versi, non più satirici, ma di osservanza.
(L’altro è Orazio satiro che vene…Dante).
La franchezza dell’ispirazione, la luminosità espressiva del linguaggio, l’accusata, lieve malinconia tra le sue pagine più ‘allegre’, a mio avviso, manifestano una delle più belle produzioni letterarie e il pieno carattere culturale del Giusti.