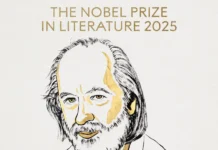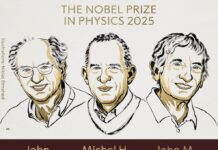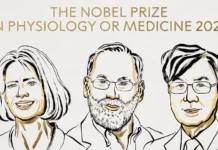Lettera aperta di una giovane al Ministro Poletti, che prima non vuole giovani italiani “tra i piedi” e poi chiede scusa.
Pubblichiamo quanto ci scrive una giovane lettrice che ci chiede di restare anonima:
Lunedì 19 Dicembre, mentre mi annoiavo durante un viaggio di ritorno a casa dalla Capitale, ero lì con il mio smartphone che aggiornavo e riaggiornavo la mia home delle notizie di Facebook. Sono solita farlo quando mi annoio, spero sempre che per ogni aggiornamento appaiano notizie belle o per lo meno interessanti.
Bene, ieri la notizia mi è stata servita su un piatto d’argento: era un articolo de “Il Fatto Quotidiano” ove leggevo: «Poletti: “Giovani italiani vanno all’estero? Alcuni meglio non averli tra i piedi”. Poi si scusa». Ero lì attonita tra il divertito e l’inorridito. Ho letto più articoli sull’argomento, quasi sperando che quelle parole non fossero mai uscite dalla sua bocca, per poi apprendere che per lui era un modo per sottolineare che chi rimane non è un “pistola”. In sintesi, il Ministro del Lavoro Italiano afferma che i 100mila giovani italiani emigrati all’estero non siano solo i famigerati “cervelli in fuga”, ma anche gente che è meglio non avere più tra i piedi.
No, non è una barzelletta. Il nostro Ministro del Lavoro, piuttosto che mettersi una mano sulla coscienza davanti a un numero così elevato di giovani che vanno via, si è permesso di dire che alcuni non sono nemmeno una perdita così importante.
Mi sono sentita ferita.
Mio fratello 25enne, infermiere, è da quasi due anni in Inghilterra con un contratto a tempo indeterminato in un ospedale pubblico. È un giovane emigrato che ha trovato la fortuna.
Ricordo ancora il giorno della partenza: la felicità mista a tristezza, la paura mista all’eccitazione, la nostalgia già nell’aria nonostante non fosse cambiato ancora nulla. Me li ricordo ancora gli occhi di mia madre gonfi di lacrime mentre cercava di nascondersi da mio fratello. Le sue parole mi risuonano nella testa da quel giorno: «Sono 30 anni che paghiamo i contributi allo Stato e mio figlio deve andar via per trovare lavoro». Ricordo benissimo la sensazione di impotenza, i tentativi di consolazione: «Ha trovato un lavoro, devi esserne felice», «E se non torna più?», il silenzio, lo sguardo terrorizzato, l’abbraccio in aeroporto.
Sono passati quasi due anni e mio fratello ha trovato la felicità, nonostante la nostalgia di casa. Fa il lavoro per cui ha studiato, ne è gratificato, è rispettato ed è stimolato a fare sempre meglio. Però è lontano. Con lui quell’anno sono partiti altri 70 infermieri italiani. Altrettanti ne erano partiti prima e altrettanti continuano a partire da due anni a questa parte. In un Paese in cui c’è una carenza di più 60mila infermieri, questi non trovano lavoro e sono costretti ad emigrare.
Poi ci sono io: ho 23 anni, sono una professionista sanitaria, lavoro da sei mesi e lo farò sicuramente per i prossimi sei mesi in un ospedale privato accreditato. Dovrei ritenermi un’italiana privilegiata, ma non riesco a pensarlo. Ho turni di lavoro massacranti, che troppo spesso raggiungono anche le 17 ore giornaliere (con le notti incluse), riposi saltuari, ferie inesistenti, paura di chiedere un giorno di malattia perché si è a contratto a tempo determinato e si temono ritorsioni. Vedo reparti sovraffollati, personale medico e sanitario stanco e affranto, gravosa carenza di materiale sanitario (inclusi i Dispositivi di Protezione Individuale). Pago tasse di iscrizione ai concorsi pubblici per UN POSTO, tasse che di economico hanno ben poco, da aggiungere al costo dei mezzi di trasporto e del pernottamento per poter affrontare le eventuali 4 prove.
«È la gavetta» mi sento dire, basta guardare le mie colleghe madri di famiglia per capire che è una condizione permanente e che va sempre più peggiorando.
Caro Ministro, piuttosto che riflettere se la partenza di questi 100mila giovani sia una fortuna o una sfortuna per l’Italia, la inviterei a pensare e ad attuare delle soluzioni valide affinché la scelta di andare all’estero non sia l’unica chance per lavorare e vivere bene, ma una scelta personale non indotta dalla condizione italiana. Cominci a considerare questi 100mila giovani, 100mila sconfitte personali.