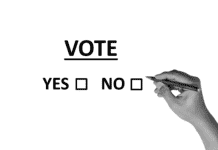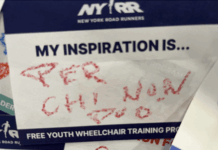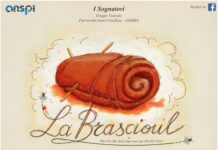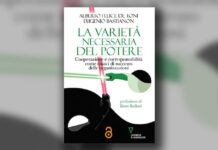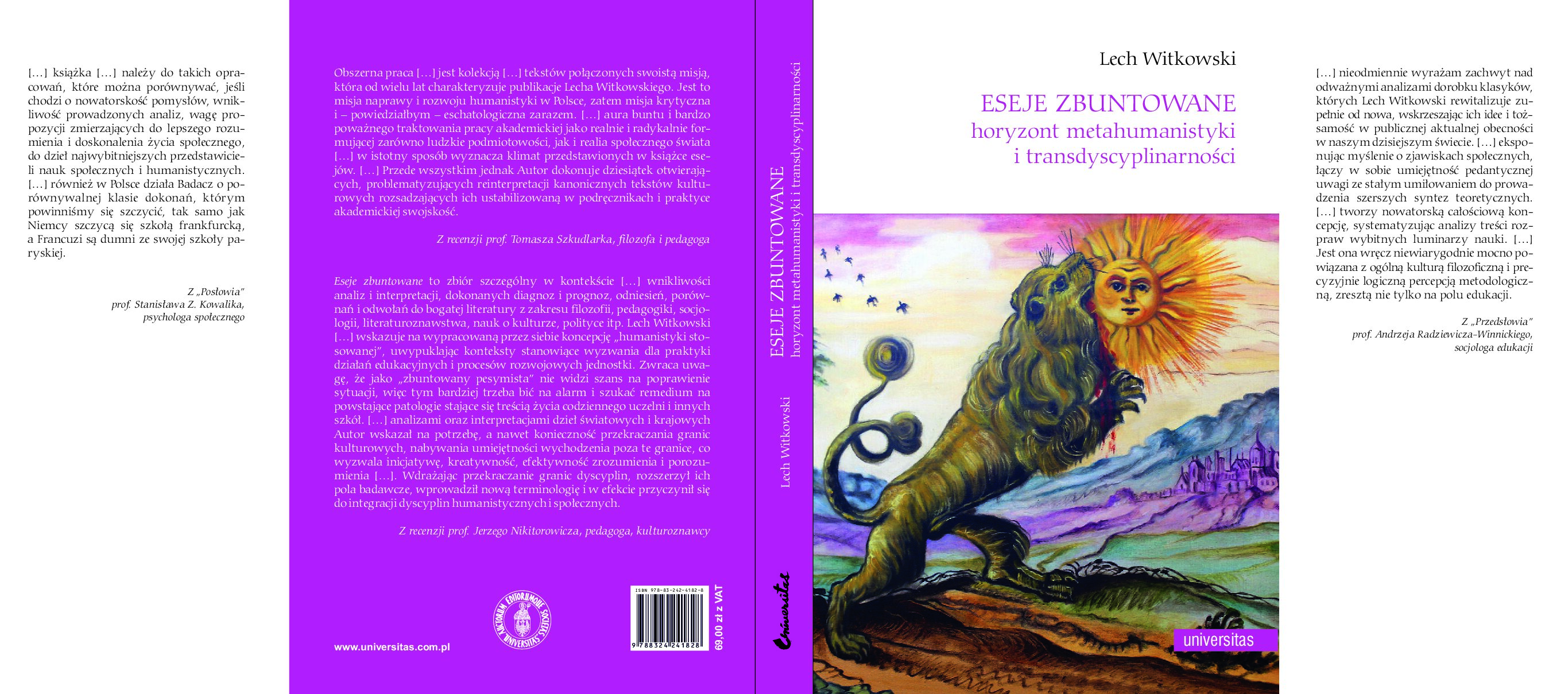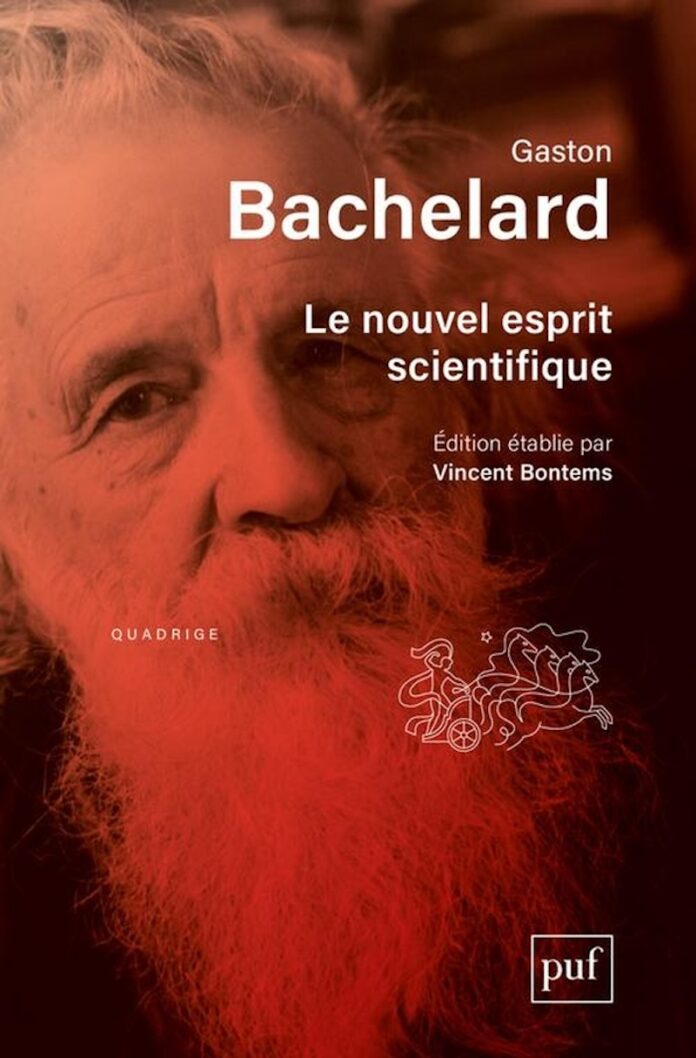
Un primo passo verso i meandri della complessità
Quando si è in grado di partorire un’idea, fatto implicito nella sua origine sanscrita (idā) come frutto della triplice funzione semantica di vedere, conoscere e comprendere, è dovuto all’inevitabile incontro-scontro con la realtà che ci circonda; pertanto, non può ‘mentire’ su di essa, a dirla con Simone Weil, e ci conduce su sani sentieri inesplorati ma solo a condizione di interrogarla con strumenti appropriati. Nello stesso tempo, per continuare ad essere tale e non risolversi in un apparato ideologico, deve rafforzarsi, sul piano dei contenuti sia di natura esistenziale che cognitiva, grazie alla crescente presa in carica delle ‘mille ragioni del reale, che non furono mai isperienza’, come ha affermato Leonardo da Vinci in degli scritti sulla natura; tali scritti in genere poco noti e se visti alla luce della situazione odierna si possono rivelare ancora di forte impatto ermeneutico nel riorientare gli stessi percorsi di ricerca sempre più tesi a ‘sopportare quasi ogni come alla luce di un perché’, per parafrasare uno dei tanti pensieri di Nietzsche. Tali intrinseche ‘ragioni del reale’ hanno bisogno in ogni caso del faticoso ‘travaglio dei concetti’ per emergere nella loro crucialità e superare l’apparente semplicismo dei dati e la loro dittatura se non vengono inseriti in un contesto teorico, per parafrasare un’espressione del matematico ed epistemologo Federigo Enriques; del resto, come avevano già avvertito i Maestri Greci e poi ribadito con forza da Karl Marx nelle prime pagine de Il Capitale, il pensiero e la scienza stessa sarebbero superflui ‘se l’apparenza e l’essenza delle cose coincidessero’.
Ed una di queste idee, implicita nel reale ed in ogni reale sia umano che naturale, è stata ed è la complessità che nell’accezione leonardiana rimanda alle sue ‘mille ragioni’ quasi come sfida nel cercare di coglierlo nella sua totalità, pur accompagnata dalla coscienza critica dell’impossibilità di una impresa del genere; del resto essa è stata e continua ad essere croce e delizia dei percorsi messi in atto nel senso che, avvertita in modo spontaneo e nello stesso tempo cogente insieme come ‘apparenza ed essenza delle cose’, si è fatto di tutto per espellerla dagli orizzonti concettuali e dalle nostre stesse vite non cogliendola come evento di verità (La complessità come evento di verità, 9 aprile 2020 e La complessità come disinfettante, 27 agosto 2020) e senza ‘farne tesoro col comportarci da sciocchi’, a dirla con un passo dei Proverbi. Come intera umanità, invece di tradurla in un progetto di vita nei vari campi dell’umano per le sue potenzialità, siamo stati quasi spaventati d’averla come costante compagna di viaggio in quanto percepita come fonte di perturbazioni, di incertezze ed in continua evoluzione col trovare in certa Modernità, nel senso avanzato da Stephen Toulmin (Rileggere la nostra storia col dono agapico della complessità, 28 marzo 2024), preziosi alleati sia di natura culturale che politica per arginarla nel creare artificiosi muri di vero e proprio contenimento. E ci è costato un duro lavoro nel campo filosofico e scientifico per ridarle il giusto peso teoretico e, in primis, lavoro soprattutto teso a ‘stanare il paradigma della semplificazione’ messo in atto, in quanto immessi, quasi malgrado, con forza nel ‘tempo della complessità’, come lo ha chiamato Mauro Ceruti, che ancora non trova molti e degni ‘scolari’, a dirla con Antonio Gramsci, per viverla e praticarla nei vari contesti in cui ci troviamo ad operare.
Per questo, una volta costruiti dei più giusti binari per pensarla, liberi da molti vincoli, e con essa il pensiero della complessità, per parafrasare Karl Kraus, e diventato in senso kantiano ‘luogo dell’intelletto’ e ‘ragione complessa’, sta entrando sia pure a fatica nel nostro ‘piccolo pantheon portatile’, per usare un’espressione di Alain Badiou; ma per risultare vincente e convincente, essa va vissuta per il pieno portato di relazionalità che porta con sé ed un primo risultato di natura fortemente antropologica che si ottiene è quello di allontanare dai nostri orizzonti ogni forma di hybris e la conseguente ‘filosofia di potenza’ che inevitabilmente l’accompagna e che ancora oggi trionfa, come ha scritto recentemente Mauro Ceruti nel ricordare l’anniversario della bomba di Hiroshima, e che come sempre si alimenta della nostra incapacità di far fronte ad un mondo in continua trasformazione. Ci vogliono, pertanto, dei volti reali che la indichino, che la abitino nel senso weiliano e soprattutto che la incarnino nelle scelte concrete per portarci fuori dalle diverse secche sia concettuali che esistenziali o ‘segmenti morti’ in cui ci siamo infilati per nostra stessa scelta, a dirla con Edgar Morin.
Tra i volti reali che l’hanno individuata sia sul terreno epistemico che su quello antropologico come condizione dell’umano in generale è stato Gaston Bachelard negli ’30 del secolo scorso, anni non a caso attraversati da altre più note figure considerate grossolanamente come ‘stregoni’, con metterle nello stesso calderone, da Wolfram Eilenberger come Wittgenstein, Cassirer, Benjamin e Heidegger per aver averci offerto una non comune diagnosi delle cause di quegli ‘anni bui’ e aver portato a termine quella che si ritiene essere stata ‘l’ultima rivoluzione del pensiero’. Ma le rivoluzioni del pensiero e nel pensiero, a cui concorrono diversi e non lineari fattori anche di ordine storico-sociale, sono il faticoso frutto della presa in carico delle ‘mille ragioni del reale’ che nessuna pur sofisticata impalcatura filosofica è in grado di far venire a galla se non si nutre continuamente di quei ‘fili del vero’, nel senso di Leonardo Da Vinci, raggiunti dal patrimonio scientifico prodotto dalle varie scienze. Esse nel fornirci di conoscenze che vanno sempre più in profondità nelle viscere del reale sono, pertanto, un coacervo di contenuti veritativi contrassegnati da una forte dose di discontinuità e ‘rotture’ concettuali per Bachelard, a volte molto difficili da digerire oltre a procurare salutari decentrazioni (Il ruolo trainante delle decentrazioni, 17 novembre 2022), in quanto sia pure a fatica stanno coniugando sempre più il ‘come’ delle cose col loro intrinseco ‘perché’ che, espulso dalla finestra da una certa Modernità, sta rientrando dalla porta principale da richiedere una nuova immagine della scienza e dell’umano più in generale, qualitativamente diversa.
Non caso, Bachelard ha gettato le basi di quella che ha chiamato ‘epistemologia non-cartesiana’ ed in tutte le sue opere epistemologiche non ha fatto altro che spianare la strada alla complessità colta come il frutto più maturo del continuo incontro-scontro con il reale, tale da vederlo da parte di Edgar Morin come uno dei suoi ‘dieci filosofi’ con l’invitarci a farlo nostro (Come ‘svegliarci’ grazie al fare nostri ‘i miei filosofi’ di Edgar Morin, 29 dicembre 2022) ; essa nell’itinerario di pensiero messo in atto si è così manifestata come “progetto”, anzi con una pluralità di ‘progetti’ visti prima come un vero e proprio dono portato in dote al nostro corredo concettuale dalla rivoluzione apportata dalle geometrie non-euclidee, non a caso considerate per diverso tempo ‘geometrie da manicomio’, e poi da quella ancora più radicale messa in atto dalla nascente meccanica quantistica o ‘schola quantorum’, così definita quando la insegnava ai suoi studenti liceali già sul finire degli anni ’20. Il lungo confronto con tali rivoluzioni scientifiche e, soprattutto, il loro insegnamento grazie allo stretto contatto con delle giovani menti, gli hanno fornito gli strumenti per mettere in campo quella che ha chiamato “una pedagogia basata sull’esercizio della trasformazione” che dal piano cognitivo deve estendersi in ogni campo dell’umano; si delineano, infatti, le basi di una integrale “rivoluzione dello spirito umano” e della ragione tout court con la conseguente necessità di una nuova Paideia da costruire ab imis in ogni campo. Infatti, molti suoi lavori sono incentrati sul lavaggio del nostro cervello per liberarlo dalle incrostazioni filosofico-scientifiche del passato, comprese quelle dello stesso linguaggio considerato a sua volta un loro potente traduttore in luoghi comuni, per il relativo pesante fardello di obsolete categorie che poi sono diventate il perno delle nostre attitudini nella vita quotidiana col farci disallineare dalla crescente complessità intorno a noi.
La complessità è stata già vista come un lievito latente nelle sue prime opere che si caratterizzano nel presentare ottiche diverse da quella Standard del tempo nel leggere le vicende delle matematiche e della fisica per coglierne il novum emergente; e l’entrata nei suoi meandri da parte di Bachelard, quando ancora era ben lungi dal panorama epistemologico del ‘900, si manifesta in particolar modo nell’introduzione dal titolo ‘La complessità essenziale della filosofia scientifica’ alla sua opera più nota, che ha avuto oltre trenta edizioni in Francia ed è stata ristampata ancora una volta in una nuova edizione critica, come Le nouvel esprit scientifique del 1934 (a cura di Vincent Bontems, Paris, PUF 2020 e a sua volta già giunta alla quarta edizione), tradotta in italiano e riproposta a più riprese nel nostro panorama culturale a partire dagli anni ’50, dove però non è stata recepita nella sua radicalità col perderne le relative poste in gioco nei vari settori. E anche se non si può misurare la validità di un’opera in base al numero delle ristampe e edizioni critiche, è pur tuttavia indice e segnale di un bisogno oggettivo, oggi più che mai all’ordine del giorno in più settori, di una ‘nuova razionalità’, di un’atmosfera e di un linguaggio più in grado di far fronte ai cambiamenti radicali che se allora erano avvertiti come cruciali solo in ambito epistemico, oggi lo sono diventati ancora di più in ogni campo dell’umano. E non è solo un caso, pertanto, se in Francia da poco è in atto una riedizione critica da parte della casa editrice Presses Universitaires de France, dopo varie vicissitudini, delle diverse opere di Gaston Bachelard, operazione culturale che lo sta imponendo come una delle voci più autorevoli del panorama filosofico non solo francese per aver tracciato dei binari di pensiero dove sono state strategiche le riflessioni sulla portata culturale delle rivoluzioni scientifiche. Per il pensatore francese, le rivoluzioni, come quelle successive avvenute in altri settori scientifici e arrivate a maturazione nella scienza dei sistemi complessi come frutto dell’intreccio di più scienze dalla fisica alla biologia e alle scienze sociali, forniscono il materiale necessario per liberare la mente umana dai propri assoluti, dagli ‘assoluti terrestri’ come li ha chiamati qualche decennio fa Dario Antiseri, e dal ‘punto cieco’, per usare il titolo di una recente opera scritta a sei mani, a cui è approdata col produrre diverse forme di hybris che stanno innescando dei processi deleteri per le sorti dell’intero Pianeta.
Per Bachelard, ‘il nuovo spirito scientifico’, non facile da metabolizzare a volte da parte degli stessi protagonisti, deve trovare spazio nell’umano più in generale e fungere da lievito nel cambiare lo status quo sia personale che sociale con l’avere così un ruolo decisivo nell’autoformazione delle coscienze per creare le condizioni di fondo per un reale cambiamento; e pertanto vanno educate le stesse menti ad una più adeguata presa in carica della ‘complessità essenziale’ dei fatti che ci circondano in virtù del dono portato in grembo dalle varie scienze se vengono sempre più supportate da un deciso ‘perché’ operante al loro interno come momento di conoscenza tout court e non appiccicato dall’esterno come un intruso, solo magari perché avvertito quasi come un dovere di carattere morale per pulirsi la coscienza. L’introduzione del ‘perché’, che la ragione complessa vive come momento saliente ed imprescindibile, porta con sé la responsabilità stessa degli atti conoscitivi da parte di chi li ha messi in campo col comportare quello che lo stesso Bachelard ha chiamato cogitamus da parte della comunità savante o, come vengono chiamati ultimamente in certi ambiti della sociologia della conoscenza, personae savantes; ed oggi, di fronte alle sfide planetarie, la comunità savante è l’umanità intera che deve rendersi attivamente responsabile nelle scelte da compiere e deve mettere in atto un cogitamus universale nel ripensare il proprio destino ed elaborare nuove strategie.
Tale approccio integrale, dove ragioni della vita e ragioni del reale si coniugano, porta a limitare le derive totalitarie che spesso ci costruiamo dentro noi stessi come indicava negli stessi anni Karl Jaspers, lucido e non comune critico testimone degli anni bui del primo Novecento, che non a caso a sua volta ha delineato sulla scia kantiana le basi di un diverso rapporto tra scienza e filosofia per non ripetere gli stessi tragici errori del passato. E la piena e sana metabolizzazione ad ogni livello delle rivoluzioni scientifiche per Bachelard porta come primo dono l’umiltà conoscitiva, il dover ricominciare sempre daccapo, il mettere in atto continui processi di “rettificazione”; per questo si è definito “il filosofo delle tre ‘ri’, ricominciare, rinnovare, riorganizzare”, opzione epistemico-esistenziale che comporta ribellarsi, essere eretici ed “anabattisti” in particolar modo, eternamente “scolari” come ha scritto in diverse opere. Ha continuato, infatti, per tutta la vita a educare e aprire il suo sguardo ad altre costellazioni concettuali come l’universo poetico e, incarnandone con lo stesso atteggiamento l’esprit di fondo nel lungo confronto con la rivoluzione surrealista, è arrivato a mettere in piedi una originale critica letteraria (Gaston Bachelard, filosofo delle e tra le 24 ore, 6 agosto 2020); e per parafrasare il titolo di un’opera di Mauro Ceruti, Bachelard ha ‘danzato’ sia con la scienza che con la poesia sino a ‘creare’ preziosi antidoti per combattere il semplicismo dovunque si annidi e a darci così di questi due mondi una immagine più articolata e più legata all’umano col dare alla riflessione filosofica il non facile compito di renderli complementari, compito che per tanto tempo della sua vita ha cercato di espletare e che ci ha lasciato in eredità.
In tal modo si è fatto apostolo della complessità con lanciarla negli anni ’30 senza nessun timore e quasi da solo con avvertirci che il primo passo necessario da compiere è quello di distruggere sistematicamente gli ‘ismi’ messi in campo in ogni angolo della nostra vita a partire dal pensiero se esso si nutre dei contenuti veritativi che gli portano in dote sia le scienze che il mondo poetico; il suo intero engagement, il combattere per “una ragione aperta” o souple, che chiamava surraison nel farsi carico della pluralità dei livelli del reale per il continuo rendere sempre più “veritiere o verità di diritto le verità di fatto” come ha scritto nella sua ultima opera di carattere epistemologico, è sì una strada per farci prendere coscienza dei nostri limiti, per far fare un salutare bagno di umiltà alle nostre pretese totalizzanti, ma è, soprattutto, un modo per uscire dai molteplici ‘segmenti morti’ a cui siamo approdati per mancanza di un pensiero adeguato alla realtà. E anche se nei suoi scritti Gaston Bachelard spesso critica aspramente sia i filosofi, perché accusati di essere legati a delle vuote “generalità”, che gli stessi scienziati perché a loro volta ancorati al “regno dei fatti”, lo fa perché diventino sempre di più ‘soggetti che studiano’, come afferma per sé stesso, per proteggersi dalle pseudo-verità sempre in agguato, avvertimento che si sta rivelando sempre più attuale; dallo studiare sempre più le ‘mille ragioni del reale’ se ne possono ricavare dei ‘progetti’ senza i quali il ‘come’ ed il ‘perché’ delle cose non dialogano col confinarci in sterili recinti che ci incanalano solo in attitudini violente col restare impotenti verso le sfide che ci attendono.