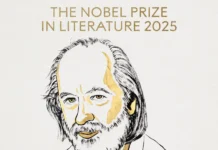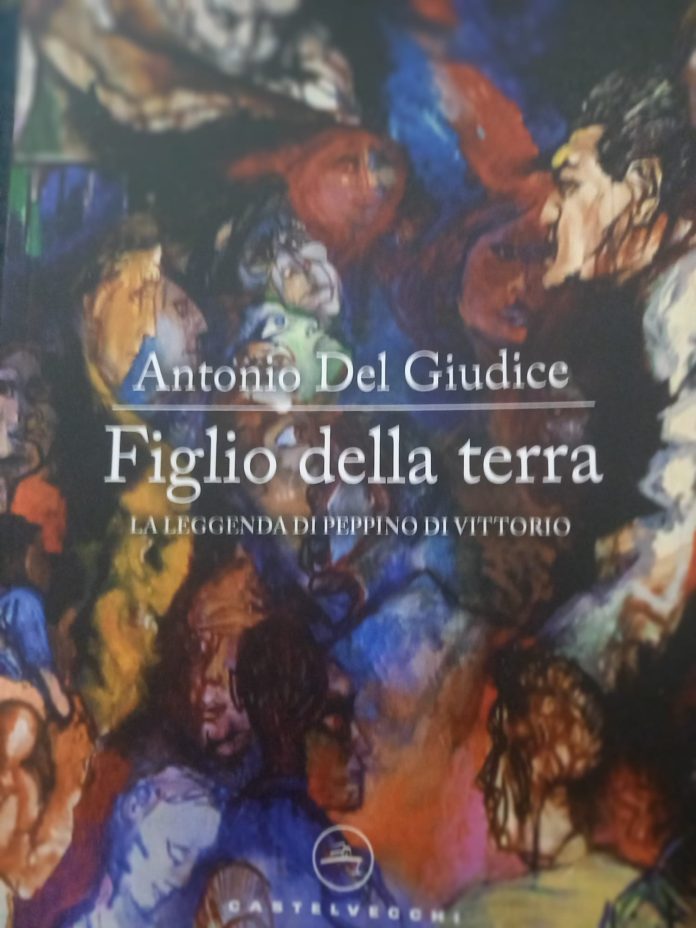
Dopo “Buonasera, Dottor Nisticò”, “La pasqua bassa” e “Il ragazzo che rubava le parole”, Antonio Del Giudice torna all’editoria con un nuovo libro. “Figlio della Terra” (Castelvecchi Editore) è, infatti, il ritratto di una figura di riferimento del sindacato del Primo Dopoguerra. La leggenda di Peppino Di Vittorio si racconta così, con la storia che affonda le radici nella tradizione popolare, il pensiero critico della gente per la gente, la cum passione per gli ultimi, i più deboli, i più veri.
Ciao, Antonio. Perché hai deciso di scrivere “Figlio della Terra”?
“Figlio della Terra” nasce da una storia di un ragazzo, che poi sono io, che ha otto anni quando sbircia dalla persiana di casa della nonna un interminabile corteo funebre, uomini donne ragazzini, con una gigantesca foto di un uomo in giacca camicia bianca e cravatta nera. Una immagine che il ragazzo non cancellerà dalla sua mente per tutta la vita.
Come descriveresti, umanamente e politicamente, la figura di Peppino Di Vittorio?
Peppino Di Vittorio è stato un gigante di altruismo e di solidarietà senza limiti verso i suoi simili, negli anni della fame e dello schiavismo di agrari e latifondisti, che trattavano uomini, donne e ragazzi non meglio dei loro animali. Forse trattavano meglio gli animali.
Ex post, credi che se, il 7 marzo 1946, Di Vittorio, con la sua capacità di smascherare i giochi di potere dei latifondisti, e a farsi portavoce dei braccianti agricoli, avesse tenuto quel comizio, si sarebbe potuto evitare l’omicidio delle Sorelle Porro?
È un’ipotesi che rimane senza risposta. Peppino arrivò per un comizio, ma non fece in tempo a fermare i braccianti esasperati dalle paghe da miseria e spinti ad uccidere le povere sorelle da capisquadra che avevano imboccato una strada da carnefici, fuori da ogni ragione. Le povere sorelle superstiti ebbero la forza di perdonare gli assassini. Credo sia l’insegnamento migliore che ci lascia ancora oggi quella tragedia.
Cosa differenzia “Figlio della Terra” da “Buonasera, Dottor Nisticò”, “La pasqua bassa” e “Il ragazzo che rubava le parole”?
Sono storie connesse che raccontano fasi della vita di un tempo mio coetaneo. Diciamo che nei tre romanzi racconto una generazione. I nati nel secondo dopoguerra, ognuno a suo modo, hanno tutti osservato e partecipato al passaggio dalla civiltà contadina alla modernità dell’oggi, dalla zolla all’intelligenza artificiale. Lo scopo della mia scrittura è identico a sempre: conservare la memoria dalla zolla dei nostri nonni all’intelligenza artificiale dei nostri figli e nipoti.