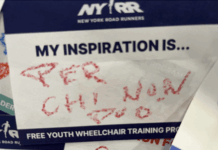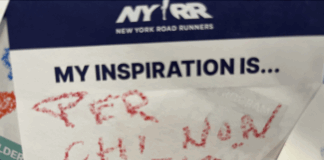Un ricordo a 18 anni dalla scomparsa.
Il giornalismo piange spesso in silenzio da adulto i suoi figli. Il giornalismo muore spesso in corpi di uomini e donne che perdono la vita per provare anche soltanto a raccontare e ad affermare la verità. E spesso il giornalismo viene esiliato da omuncoli che non hanno doti particolari a parte il denaro e il potere.
Vorrei ricordare il padre che avrei voluto avere oltre il mio biologico. Vorrei ricordare un padre del giornalismo italiano. Mi permetto di offendere taluni puritani del giornalismo, usando, per cercare informazioni che ignoro, un po’ dell’IA di Copilot della Microsoft. Non è copiare o rubare, gli ho spiegato cosa restituirmi. Sto imparando ad usarla e a governarla. Mi ha dato i mattoni. Il cemento è il mio. Il giudizio il vostro. La tecnologia può aiutare solo chi usa quel po’ di cuore che gli rimane. E devo chiedere scusa a Paolo, il mio direttore, ma chi guida questa macchina di parole e punteggiatura è il motore della mia vita interiore. Non è in vendita. Nessun algoritmo può comprarlo.
Il 6 novembre 2007 si spegneva a Milano Enzo Biagi, uno dei pochi Padri del giornalismo italiano. Testimone del Novecento. Partigiano. Scrittore. Conduttore televisivo. Cronista. A diciotto anni dalla sua scomparsa. Alcuni non ne sentono la mancanza. A me manca.
L’informazione è tuttora piegata agli interessi del potere e ricordare Biagi significa riscoprire il valore della verità, della responsabilità e del coraggio civile. Un cancro che semina metastasi. La medicina è l’umanità che quattro pezzenti hanno barattato con azioni e assemblee di soci.
Questo uomo mite, gentile, educato e colto e coraggioso. Nasce il 9 agosto 1920 a Pianaccio, frazione di Lizzano in Belvedere, sull’Appennino bolognese. Cresce in una famiglia umile. Il padre è magazziniere in uno zuccherificio, la madre casalinga. Fin da ragazzo mostra una spiccata inclinazione per la scrittura e una precoce coscienza civile. L’idea di diventare giornalista gli nasce leggendo Martin Eden di Jack London. A 17 anni inizia a scrivere per L’Avvenire d’Italia, e a 21 diventa giornalista professionista.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, entra nella brigata partigiana Giustizia e Libertà, esperienza che segnerà profondamente la sua vita e la sua visione del mondo. “Quei quattordici mesi da partigiano mi hanno accompagnato per sempre”, dirà. La Resistenza non fu solo un capitolo della sua biografia, ma il fondamento etico del suo giornalismo.
Nel dopoguerra, lavora per Il Resto del Carlino, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Panorama, L’Espresso. Dirige Epoca dal 1953 al 1960, diventando il più giovane direttore di un settimanale nazionale. Nel 1961 entra in RAI come direttore del Telegiornale, dove introduce innovazioni decisive: la cronaca nera, i collegamenti internazionali, le inchieste sociali. È tra i primi a portare in TV giornalisti della carta stampata come Montanelli e Bocca.
Dal 1995 al 2001 conduce Il Fatto, programma televisivo che diventa un punto di riferimento per l’informazione libera e critica. Con oltre 700 puntate, Biagi costruisce una vera “cattedra civile”, da cui osserva e racconta l’Italia con garbo, fermezza e ironia.
Il giornalismo di Biagi si distingue per uno stile sobrio, diretto, ma mai banale. Sapeva rendere comprensibili eventi complessi, parlando al cittadino comune senza rinunciare alla profondità. “Bisogna avere un punto di vista, altrimenti una storia non la si può raccontare”, diceva. Il suo modo di intervistare era arricchito da una sottile ironia, che rendeva le relazioni umane più efficaci e coinvolgenti.
Il 18 aprile 2002, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi accusa pubblicamente Biagi, Santoro e Luttazzi di aver fatto “un uso criminoso della televisione pubblica”. È il famigerato “editto bulgaro”, che segna l’inizio di un periodo buio per il pluralismo dell’informazione. Biagi viene allontanato dalla RAI con una raccomandata, senza possibilità di replica.
“L’atto più miserabile che si può fare a un uomo è togliergli il lavoro”, dirà, non per sé, ma per i giovani colleghi che non hanno la sua notorietà. Il suo allontanamento diventa il simbolo della subordinazione della TV pubblica al potere politico. Biagi aveva previsto tutto: “Se fanno questo a me, che sono Biagi, cosa faranno ai giovani giornalisti che si rifiutano di eseguire gli ordini?”
Aveva la colpa degli esseri umani: pensare tra chi comanda. Ha raccontato l’Italia senza sconti, con amore. “Cara Italia, perché giusto o sbagliato che sia, questo è il mio paese con le sue grandi qualità e i suoi grandi difetti.”
Amava ripetere che “un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza e la criminalità, impone ai politici il buon governo”.
Impariamo. A vivere e ad essere liberi. La verità sazia ed è gratis.