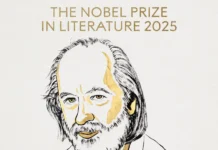La legge italiana sull’IA e il pensiero dei Papi Leone XIV, Francesco e Benedetto XVI sul rapporto uomo-tecnologia
Il 10 ottobre è entrata in vigore la prima legge italiana sull’intelligenza artificiale cosiddetta generativa, ossia la legge numero 132 del 2025, e in questi giorni si stanno avvicendando i primi commenti al riguardo. La maggior parte di coloro che si esprimono sull’IA sono economisti, informatici, giuristi, ingegneri. Ma l’auspicio, come ho detto nel mio discorso in Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani in Senato il 30 ottobre pomeriggio, in un convegno dedicato all’IA nelle sfide istituzionali sulla regolamentazione del potere algoritmico, è anzitutto di carattere antropocentrico e umanista.
Inizio con il darvi una buona notizia. Le scienze informatiche, tecnologiche, la robotica, le scienze giuridiche, quelle psicologiche e sociologiche, l’algoretica e via dicendo, non sono sole, perché non sono le sole ad occuparsi dell’impatto dell’intelligenza artificiale cosiddetta generativa nella vita delle persone in carne, ossa e spirito. Insieme a tutte le voci c’è una voce autorevole che si occupa del benessere sociospirituale di individui e popoli: è la voce della Chiesa cattolica, con il Papa Leone XIV. Il Cardinale Prevost, una volta eletto Papa, ha scelto il nome di Leone anche perché viviamo immersi in una nuova rivoluzione, quella dell’intelligenza artificiale.
L’11 maggio 2025, durante l’omelia della messa celebrata nella Cripta della Basilica di San Pietro, Papa Leone XIV ha detto: “Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse sono le ragioni, però principalmente perché il Papa Leone XIII, con la storica Enciclica Rerum novarum (del 15 maggio 1891, n.d.a.), affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale (la prima vera, la principale, si intende, n.d.a.); e oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro”.
Per difendere quella dignità umana, il lavoro e la giustizia, l’Italia è stato il primo Stato tra i Paesi membri dell’UE ad emanare una legge organica sull’intelligenza artificiale, la legge n. 132 del 2025 entrata in vigore il 10 ottobre. È una legge di chiara matrice antropocentrica e umanista, che si pone in armonia sì con il Regolamento UE num. 1689 del 2024, l’AI Act, ma è una legge che si pone in tenace armonia anche con le preoccupazioni del Papa. Un esempio fra tutti è il settore della giustizia, su cui la legge all’art. 15 ha espressamente statuito che “nell’attività giudiziaria ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti” è sempre riservata non ad un sistema di IA ma ai magistrati esseri umani, speriamo al più presto all’interno di una Magistratura dalle carriere ben separate.
Il 21 giugno 2025, mentre io festeggiavo il mio onomastico per San Luigi Gonzaga e voi l’inizio dell’estate, Papa Leone XIV nel suo discorso rivolto ai partecipati al Giubileo dei Governanti nell’Aula delle Benedizioni del Palazzo Apostolico, ha affermato che: “L’intelligenza artificiale rimane dotata di una “memoria” statica, per nulla paragonabile a quella dell’uomo e della donna, che è invece creativa, dinamica, generativa, capace di unire passato, presente e futuro in una viva e feconda ricerca di senso”.
Di quella ricerca di senso si era occupato anche Papa Francesco. Ricorderemo tutti il G7 di giugno 2024 presieduto dall’Italia a Borgo Egnazia, in Puglia, dove il Papa ha parlato di etica e IA, ed era la prima volta che un Pontefice parlasse ad un G7. Ma su Papa Francesco voglio darvi una notizia meno battuta. Come vari sapranno, nel 2019 è stato pubblicato il Documento sulla Fratellanza umana, frutto di uno specifico dialogo iniziato dal 2013 tra il mondo cattolico vaticano e una parte delle alte sfere del mondo musulmano, ovviamente quello non fondamentalista. Fonti attendibili ci dicono che Papa Francesco stava lavorando per un nuovo documento, sempre cattolico-musulmano, dedicato proprio all’etica nell’utilizzo dell’IA. Sul Nàtional Càtholic Règister a inizio ottobre è uscito un articolo-intervista al giudice Mohamed Abdelsalam, Rappresentante Superiore del Grande Imam della moschea Al-Azhar del Cairo. Quel giudice islamico ha preso parte ai colloqui che hanno portato al Documento sulla Fratellanza Umana, e al Register ha dichiarato quanto segue: “Oggi sta emergendo un nuovo documento incentrato sull’etica dell’intelligenza artificiale. (…) il Grande Imam ha affermato di aver già discusso con il defunto Papa Francesco e il Vaticano l’elaborazione di un documento sull’etica dell’intelligenza artificiale, volto a proteggere le generazioni presenti e future e a incoraggiare l’adesione ai principi etici e religiosi di fronte al rapido progresso tecnologico. Il documento era quasi completo e la sua pubblicazione era prevista, ma la scomparsa di Papa Francesco ne ha ritardato l’annuncio. Siamo attualmente in stretto contatto con il Vaticano per riprendere e finalizzare questo importante progetto”.
Ma non dimentichiamoci del più grande teologo del Novecento: Ratzinger, Papa Benedetto XVI, lungimirante sull’Europa ma anche sul rapporto tra la tecnologia e l’essere umano.
Nell’Enciclica Caritas in veritate Benedetto XVI, tra le varie cose, aveva scritto quanto segue: “Lo sviluppo tecnologico può indurre l’idea dell’autosufficienza della tecnica stessa quando l’uomo, interrogandosi solo sul come, non considera i tanti perché dai quali è spinto ad agire. (…) Il sapere non è mai solo opera dell’intelligenza. Può certamente essere ridotto a calcolo e ad esperimento, ma se vuole essere sapienza capace di orientare l’uomo alla luce dei principi primi e dei suoi fini ultimi, deve essere “condito” con il sale della carità. (dove per carità intendiamo la forma più alta di amore, n.d.a.) (…) Le esigenze dell’amore non contraddicono quelle della ragione. (…) C’è bisogno di spingersi più in là: lo richiede la carità nella verità. (…) Non c’è l’intelligenza e poi l’amore: ci sono l’amore ricco di intelligenza e l’intelligenza piena di amore”.
Ricordiamoci sempre che solo l’intelligenza umana ha la capacità ontologica di sperimentare l’amore, in quanto tale capacità intrinseca ad un soggetto, mentre l’intelligenza artificiale è e resterà un oggetto, seppur complesso e virtuale.
A margine delle anzidette citazioni autorevoli, permettetemi alcune considerazioni più personali: i meccanismi dell’IA sembrano scimmiottare le dialettiche della coscienza individuale e dello spirito, pur avendo natura e conformazioni in realtà differenti: facendo la domanda giusta si ha una risposta più o meno appropriata.
In Cina di recente hanno inserito l’IA come materia scolastica a sé per i bambini che frequentano le scuole equivalenti alle nostre scuole elementari. È legittimo però domandarsi se quei bambini, in un’età fragile, avranno gli strumenti culturali e di algoretica per discernere i meccanismi della propria psiche, del proprio io, della propria coscienza e del proprio spirito dai meccanismi del mondo virtuale dell’IA. Su questi temi si gioca lo scarto tra maturità della nostra civiltà e alienazione umana, e conseguentemente si gioca anche il futuro delle classi dirigenti.
C’è sì il reato di deepfake, di cui all’art. 612-quater del codice penale, che punisce con la pena della reclusione fino a cinque anni la illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di IA, ma non tutti i video, gli audio e i testi falsi che gireranno sul web o sui canali privati verranno individuati e denunciati come fake. Ma tantissimi contenuti immessi in rete diventeranno i mattoni costitutivi di un sostrato cibernetico da cui l’IA andrà a reperire materiale con cui rispondere alle curiosità di chicchessia, soprattutto dei più ingenui o dei più giovani.
Utilizziamo l’IA per accrescere le opportunità nella libera impresa, senza minare la stabilità dei posti di lavoro. Utilizziamola per efficientare e velocizzare la pubblica amministrazione. Ma restiamo solidi nella nostra capacità di discernimento e nel difendere la natura, la realtà e l’umanità, che sono le nostre radici, che sono la nostra identità.