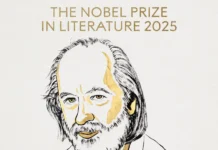MEMORIA CORTA
Nell’inverno del 1945 l’avanzata sovietica era ormai inarrestabile.
Dopo la battaglia di Stalingrado, snodo chiave sul fronte orientale, l’esito della guerra pendeva a favore degli Alleati che, con lo sbarco in Normandia, soffocarono in una tenaglia mortale la Wehrmacht. L’Armata Rossa finì per travolgere qualsiasi cosa che trovasse sul proprio cammino e spalancò anche quelle porte che volutamente erano state tenute nascoste al mondo, come i battenti dei campi di concentramento, sui quali campeggiava con aria sinistra e menzognera il motto Arbeit Macht Frei, il lavoro rende liberi. Il 27 gennaio l’esercito sovietico entrava ad Auschwitz, il più noto dei lager nazisti, e rivelò al mondo gli orrori della folle ideologia del Reich, la peggiore umiliazione della persona che mente umana avesse mai messo in atto.
La Repubblica italiana, con la legge 211 del 20 luglio 2000, ha istituito il Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, nelle modalità previste dall’articolo 2 della stessa legge: “sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.” Da allora abbiamo imparato a dare voce ai testimoni, a ricordare il triste passato di tanti ebrei che hanno fatto del memoriale continuo del loro passato uno dei fulcri sul quale si poggia la loro fede. Per gli ebrei fare memoria non è solo un mero atto rituale ma è rivivere nell’oggi gli eventi che hanno segnato la storia del popolo eletto, come avviene nella celebrazione annuale del Seder, attualizzazione perpetua e personale del passaggio dalla schiavitù alla libertà. Dal 2000 abbiamo imparato a conoscere le storie di tante donne e di tanti uomini che da quel terrore sono tornati, che hanno riferito con coraggio ciò che avevano vissuto, come Sami Modiano, originario di Rodi, o che, dopo anni di silenzio, hanno ritenuto che fosse fondamentale raccontare, come Liliana Segre, milanese, internata nei campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau che ha iniziato la narrazione della sua esperienza soltanto a partire dagli anni 90.
La sua sopravvivenza fu dovuta ad una serie di circostanze fortuite.
Arrivata nel campo di concentramento, fu subito separata da suo padre, morto poco dopo, pertanto seguì i membri della famiglia Morais: «La signora (Morais), coi suoi due ragazzi, fu mandata a destra. Quando vidi che mi separavano da lei avrei voluto essere accanto a quella donna, ma certo non potevo chiedere: «Mi scusi tanto, io vorrei andare da un’altra parte». Rimasi impietrita, silenziosa, spaurita. La signora Morais fu mandata direttamente al gas e la sera stessa era sicuramente già cenere» (FONTE https://www.azionenonviolenta.it/ad-auschwitz-tredici-anni-racconto-liliana-segre/).
Grazie alla sua giovane età fu risparmiata dalla morte e utilizzata in alcuni lavori leggeri.

Cos’è la memoria per Liliana Segre?
Così si è espressa una volta: «Un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare…»
Ho ammirato questa figura imperturbabile.
La sua capacità di riportare eventi tragici e personali quasi con naturalezza mi ha sempre colpito e la sua testimonianza, come quella di altre voci, è un vaccino potente contro l’antisemitismo che da un po’ di tempo sembra essere tornato in Europa, ad esempio in Francia, dove la comunità si sente minacciata, soprattutto dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Parole forti quelle della Senatrice Segre, che possono aiutare a discernere il bene dal male, a fare memoria, come se quel dramma potesse essere vissuto nell’oggi perché, si spera, non torni. Anche quest’anno mi imbatterò nella lettura dei Giusti davanti alle Nazioni, il Bartali, il Roncalli o il Perlasca, esempi potenti di resistenza, e ascolterò ancora la Segre nel suo straziante ma icastico memoriale che ci ricorda l’importanza per ciascuno di noi di usare la coscienza.
Non vorrei essere pretenzioso e mancare di rispetto alla Senatrice, ma la mia coscienza, e forse quella di tanti altri, mi richiama alla mente tutto ciò che la povera gente di Gaza ha vissuto, che per il momento vive una tregua che si regge sul sottile filo di un cessate il fuoco incerto. Human Rights Watch e Amnesty International non hanno perso tempo ad accusare Israele di aver ucciso quarantamila persone, di cui oltre diciassettemila bambini, a privare la popolazione di acqua e a causare un’emergenza sanitaria.
Questa non è forse ingiustizia?
Non è sofferenza oltremodo inutile?
Molti dicono che l’accordo tra Israele e Hamas poteva essere trovato molti mesi fa e, allora, tante vite sarebbero state risparmiate e molte famiglie non sarebbero state distrutte. Liliana Segre ha espresso mesi fa la sua vicinanza per il popolo israeliano e le famiglie degli ostaggi e per i palestinesi innocenti che hanno perso tutto, ma ha anche ritenuto che l’attacco israeliano a Gaza non potesse essere considerato genocidio. Non entro nel merito di questa questione, ma sono convinto che tanti in Israele siano infettati da un virus insidioso e pernicioso, che è quello del messianismo strisciante e viscido, della politica dimentica della dignità umana e del proprio passato, gestita da signori della guerra intransigenti e senza scrupoli.
In questi giorni ricorderemo la Shoah con il solito protocollo consolidato, fatto di film in TV, incontri pubblici e riflessioni nelle classi con i nostri alunni, per non dimenticare il male di cui il genere umano è stato capace di fare, testimonianza della nostra disumanità.
In ebraico memoria si dice Zakhor, che si traduce con “ricorda”.
È un’ingiunzione, un ordine perentorio, che pone l’ebreo in una condizione ossessiva, di obbligo. Ognuno di noi dovrebbe vedersi liberato da quei soldati provenienti dall’Est e continuare a dar voce alla memoria viva dei testimoni diretti, la cui responsabilità graverà un giorno su di noi e sulle future generazioni.
È un obbligo, per tutti.
Peccato che alcuni discendenti diretti di questi testimoni abbiano la memoria corta e stiano mostrando poca attenzione, una superficialità che è frutto di una sottovalutazione degli accadimenti del passato, del loro essere stati schiavi in Egitto, dell’essere stati deportati in una Babilonia di sangue.