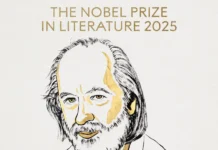L’8 marzo in in Kirghizistan
Come tutti sappiamo, oggi, 8 marzo, ricorre la Festa della Donna. Regali di mimose, pranzi e cene “tra donne”, manifestazioni: dal 1977, quando questa ricorrenza è stata istituita, osserviamo queste abitudini, nella sacrosanta intenzione di valorizzare ed esaltare la figura della donna.
Ma tutti sappiamo anche che non tutte le donne possono permettersi il privilegio di vivere le nostre tradizioni: conosciamo la situazione delle donne mediorientali e maghrebine, costrette a portare un velo per coprire il loro volto, o vittime di padri padroni che scelgono il loro sposo, o di mariti senza i quali non hanno alcun diritto.
Né tutti conoscono (e mi auguro di sbagliare) ciò che sto per esporre in questo articolo. Neanch’io ne ero a conoscenza, prima di imbattermene casualmente e documentarmene, rimanendone colpito nel profondo della mia anima.
Ci troviamo in Kirghizistan, uno Stato nato nel 1991 dallo smembramento dell’Unione Sovietica, distante migliaia di chilometri dalle nostre case, con i suoi costumi e le sue tradizioni: tra questi vi è l’Ala-kachuu (“prendi e fuggi”, in kirghiso).
Il copione è sempre il medesimo: una giovane ragazza (che, per comodità, chiameremo Ivana) passeggia sola nella periferia della capitale Bishkek. Improvvisamente, un uomo (che, sempre per comodità, chiameremo Askar) le si avvicina, le copre la bocca con il palmo della sua mano, la solleva di peso e la trascina con sé.
Subito giunge un’auto a grande velocità, guidata da uno dei fratelli di Askar. Ivana urla a squarciagola, attirando l’attenzione degli altri passanti, ma l’aiuto di cui ha bisogno non giunge. Viene caricata in auto sui sedili posteriori e portata via a gran velocità, e i passanti, come se nulla fosse accaduto, borbottano, ma subito dopo tornano alle loro faccende.
Askar e i suoi fratelli cantano felici: la loro missione è compiuta, possono finalmente tornare alla loro capanna fuori città.
Dopo svariati minuti di corsa in auto, mentre Askar tiene con forza Ivana, che lotta e si dimena senza sosta, si arriva finalmente a casa. Ad attendere Askar e i suoi fratello ci sono i loro genitori, le altre sorelle e la loro nonna. Quest’ultima tiene in mano un velo bianco, che aveva lavato con cura mentre i suoi nipoti erano “in gita”.
Askar scende dall’auto e porta in braccio Ivana. La consegna ai propri genitori, che, compiaciuti, la accompagnano in casa tenendola per le braccia, seguiti dalla nonna.
Ivana cerca disperatamente la compassione dell’anziana donna: “Vi prego, nonna, non mettetemi quel velo in testa”. Ivana sa cosa significa quel velo candido, ma le sue suppliche non vengono ascoltate. Askar le si affianca, la nonna le lega il velo attorno ai capelli, i familiari di Askar lanciano dei petali in alto: Ivana e Askar sono uniti in matrimonio. Askar ha portato onore alla sua famiglia, ma la vita di Ivana è segnata, fino alla fine dei suoi giorni.
Ivana passa la notte nella casa dei suoi rapitori, mentre i suoi genitori la staranno cercando preoccupati. Il giorno dopo, arriva il momento della visita dai genitori della sposa: la famiglia di Askar porta un montone vivo per la preparazione del piatto tipico kirghiso, il beshbarmak, e altre pietanze per il pranzo, al fine di unire le famiglie, che brinderanno a tavola augurandosi la felicità degli sposi.
Ivana è in lacrime, cerca la protezione dei suoi genitori, non si sente pronta per sposarsi a una così giovane età. Ma i suoi genitori sembrano indifferenti al suo pianto, sono felici che la loro figlia abbia un uomo al suo fianco.
Ivana, persa ogni speranza, è costretta ad accettare la sua condizione, sarà costretta a rinunciare alle sue aspirazioni per diventare una buona sposa, sarà costretta a subire una condizione di oppressione o di reclusione, e forse anche violenze. Abbandonare il suo sposo non farebbe altro che recare disonore alla sua famiglia.
Questo infame rituale si conclude con una cerimonia formale, in cui i due sposi saranno indissolubilmente uniti in matrimonio davanti all’imam, e alla presenza delle rispettive famiglie.
In Kirghizistan, secondo il Kyz Korgon Institute (organizzazione kirghisa che si occupa della repressione dell’ala kachuu), nel 2011 circa il 68-75% dei matrimoni avviene in modo non consensuale, ricorrendo al rapimento. Di queste, circa l’84% decidono di accettare la propria condizione, le restanti si rifiutano, ma finiscono per arrendersi a causa di minacce anche da parte della loro famiglia. Secondo un rapporto del 2014 del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione ha registrato un incremento del fenomeno dei matrimoni infantili collegandolo all’ala kachuu: nelle aree rurali circa il 12% delle spose è al di sotto dei 18 anni di età, e la totalità di queste non riesce a completare gli studi a causa del matrimonio. Il totale delle giovani costrette a sposare il loro rapitore ammonta a circa 12.000 per ogni anno.
In alcuni casi l’ala kachuu è sfociato in tragedia: nel 2011-2012 Venera, Nurzat e Yriys, tre donne di 20 anni hanno scelto la via del suicidio, e nel 2018 Burulai, una ragazza di 20 anni, è stata uccisa dal suo rapitore in una stazione di polizia, alla quale si era recata per denunciare il suo rapimento.
Dal 2013, l’art. 155 del codice penale kirghiso qualifica l’ala kachuu come reato punibile con la reclusione fino a 6 anni (10 anni se il rapimento è subito da un minore al di sotto dei 17 anni), ma la norma è scarsamente applicata:
- per le poche denunce che giungono in Tribunale: le spose sono vittime di forti minacce a causa delle quali rinunciano a denunciare, e molto spesso i matrimoni non vengono annotati nei pubblici registri, sia perché vengono frettolosamente organizzati, sia perché non si vogliono avere ripercussioni legali (i numeri del 2012 ammontano a soli 10 casi rinviati a giudizio);
- per lo scarso potere di dissuasione della norma: spesso negli uffici di polizia si dà la colpa alla negligenza della ragazza che si è fatta rapire, e nelle istituzioni pubbliche si dà superficiale attenzione al fenomeno, tutelato quale “bella tradizione popolare”.
Purtroppo, ancora oggi l’ala kachuu persiste in tutto il territorio kirghiso, consegnando migliaia di giovani ragazze a una vita che non desiderano. E nonostante gli sforzi delle istituzioni statali e internazionali per la sensibilizzazione e la prevenzione del fenomeno, ci troviamo ancora a un punto morto.
Oggi, 8 marzo, il mio pensiero e augurio a alla memoria di Venera, Nurzat, Yriys e Burulai, alla moltitudine di donne kirghise e di altre nazionalità a cui è negato ancora oggi il diritto di essere artefici del proprio destino, e a tutte coloro che mettono il loro impegno affinché un giorno le oppresse dispongano di questo diritto.
La mia mimosa, oggi, è dedicata a voi.