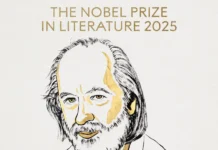Ingredienti di amicizia e familiarità
È paradossale vedere e paragonare i colori dei dolci siciliani che variano tantissimo con il marrone, quasi unico monocromo di torte o dolciumi in un posto vicinissimo come il nord Africa. C’è inoltre un altro dato interessantissimo sulle viti. Sappiamo che erano diffuse soprattutto nella zona mediterranea e, solo nell’Alto Medioevo, in tutta l’Europa. Stessa cosa dicasi del pane che si è diffuso, occupando nella storia, svariati terreni in tutto il mondo allora conosciuto.
Ma qual è la spiegazione? Gli studiosi dell’alimentazione ed anche gli storici fanno notare che la tavola è divenuta “sacra” proprio per la fede cristiana. Sono stati, infatti, i monaci a diffondere in tutta Europa la viticultura, proprio per i numerosissimi richiami biblici sulla bontà del vino, simbolo della gioia, e per il fatto che ne è la materia sacramentale per la santa messa. Stessa diffusione dicasi per il pane e per l’olio, attraverso numerosissime distese di grano e ulivi.
La tavola ha assunto un valore altissimo per la tradizione cristiana proprio perché su una tavola, Gesù, ha inaugurato la nuova ed eterna Alleanza nel sacrificio incruento del pane e del vino, segni del suo amore crocifisso e risorto. Anche l’olio, tipico della zona mediterranea, fin nel mondo greco, si è diffuso, in quanto materia sacramentale, per i riti cristiani ma soprattutto come il carburante per illuminare le grandi basiliche.
Per il calendario gregoriano, che imponeva nei periodi di penitenza la mancanza di carne, anche la tradizione nordica, fondata culinariamente sul lardo e sulla carne, ha dovuto confrontarsi, fino ad esserne assorbita, con la tradizione mediterranea. La carne, simbolo di ricchezza e forza, nei periodi detti di magra, ha dovuto lasciare il posto al pesce. È proprio grazie alle ricette dei monaci ed alla tradizione dei gruppi orientali penitenziali dei pasti puri che il pesce trova il suo giorno di consumo nel venerdì, perché è il giorno della morte di Gesù.
Poiché, inoltre, si riteneva l’acqua fonte di malattie, la si beveva sempre con il vino, considerato dai medici antichi un ottimo purificatore. Essendo il vino segno della festa, per necessità penitenziali, la sapienza monastica ha fatto sviluppare la diffusione della birra, la quale si è diffusa, successivamente, con il consumo di pizze, non perché migliore a livello culinario, ma semplicemente perché costava meno. Per quanto riguarda il vino, a differenza dei paesi anglosassoni, dalle nostre parti, il consumo è sempre in compagnia, per il retaggio della tradizione cristiana. Se si beve, nei contesti di tradizione cattolica, è sempre per relazionarsi, per incontrarsi e far festa con altri.
Credo che sia fondamentale ripensare a questi concetti che hanno definito la nostra identità europea, proprio partendo dalla tavola. Gli studi sulla felicità affermano che il momento più amato della giornata è quello del pranzo. In una società che ci spinge all’isolamento esistenziale e che fa della velocità la logica della produzione, riscoprire la ricchezza della tavola, della storia dei suoi ingredienti, la sacralità della condivisione, tornare alla tradizione cristiana, rammentare i gesti più belli che Gesù ha compiuto proprio a tavola, penso che sia fondamentale per non lasciarci derubare della preziosità del condividere.
Più che donare, sarebbe splendido condividere ciò che si ha. Nel mio paese, ad indicare l’estraneità tra due persone, un detto popolare dice: “Abbiamo mai mangiato insieme?”. Il mangiare insieme, il condividere un pasto rende amici, fratelli e famiglia. Di Gesù si diceva, accusandolo, che era un mangione e un beone. Forse proprio i cristiani, più degli altri, dovrebbero riscoprire la bellezza della tavola, del condividere, con i fatti e la verità, ciò che viene proclamato per principi ed idealizzazioni. Il pane, l’olio, il vino attraverso le nostre tavole, trovino lo spazio per continuare ad unire, rendere famiglia e donare gioia.