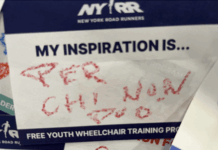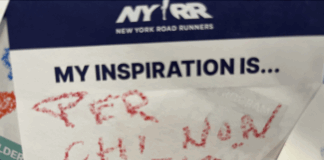Proviamo a capire cosa cambierebbe se passasse il “sì”
Il Referendum Costituzionale per cui saremo chiamati alle urne quest’autunno rischia di diventare una pietra miliare sulla quale fondare o, sarebbe meglio dire, ri-fondare la storia della nostra Repubblica. Già, perché quando lo scorso aprile il Parlamento ha approvato la Riforma della Costituzione, voluta fortemente dal Ministro Maria Elena Boschi, la sensazione era che ci si trovasse di fronte ad un cambio epocale, una modifica ritenuta così necessaria che il Primo Ministro, Matteo Renzi, e la stessa Boschi hanno minacciato le dimissioni nel caso in cui il disegno di legge non passasse.
Ma proviamo a riepilogare cosa cambierebbe, se al referendum vincesse il “sì”.
Entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, la Costituzione potrebbe essere rivista in cinque punti. La principale differenza si troverebbe nella fine del cosiddetto “bicameralismo perfetto”. Oggi, infatti, come previsto dall’articolo 70, per essere approvata, una legge deve ottenere il placet sia della Camera che del Senato. Con la Riforma, invece, il potere decisionale sarebbe interamente appannaggio della Camera, composta da parlamentari eletti dal popolo, responsabile, fra le altre cose, anche del Bilancio Statale e della possibile sfiducia nei confronti del Governo di turno.
Il secondo punto riguarda l’autonomia del Senato che diventerebbe un organo di coordinamento tra Stato e Regioni intese come enti locali. Non solo, i tagli al personale prevedono anche una diminutio nel numero dei Senatori, da 315 a 100. Questi non sarebbero eletti direttamente, 95 verrebbero reclutati dai vari consigli regionali (21 Sindaci e 74 Consiglieri), mentre i restanti 5 resterebbero in carica per sette anni attraverso la nomina del Presidente della Repubblica, il quale, a fine mandato, potrà godere del titolo di “Senatore a Vita”. Il Presidente dovrà essere eletto dai due terzi dei parlamentari fino al quarto scrutinio, se ciò non fosse sufficiente, basterebbe la maggioranza dei tre quinti, ottenuta in capo alle due camere in seduta comune.
Altro snodo essenziale è la ripartizione delle competenze fra Stato, Regioni e Autonomie locali. Quanto stabilito dal Titolo V della parte II della Costituzione era già stato corretto, ma in maniera confusa, nel 2001. Ambiente, produzione di energia, sicurezza sul lavoro e ordinamenti professionali saranno materie gestite esclusivamente dallo Stato.
Verrà abolito il Cnel (Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro), gruppo di supporto formato da 64 consiglieri, con la sola funzione consultiva di avere voce in capitolo, appunto, sulle leggi economiche e lavorative.
Per chiedere un referendum saranno ancora sufficienti 500.000, ma se i promotori ne raccogliessero 800.000 per raggiungere il quorum sarebbe sufficiente che si recassero alle urne non il 50% più degli aventi il diritto al voto, ma il 50% più uno di quanti hanno votato nelle precedenti elezioni.
Altra grande novità: l’introduzione dei referendum propositivi, esempio concreto di partecipazione diretta del popolo al processo di formazione di una legge, utile in particolare su temi di scottante attualità.
D’altro canto, per proporre un ddl di iniziativa popolare serviranno non più 50.000, ma 150.000 firme.
Piero Calamandrei ammoniva: “La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere” (Discorso sulla Costituzione, 1955).