
Il vero fallimento non è della Bolkestein, ma nostro.
Nel pieno dell’estate italiana, tra ombrelloni allineati, prenotazioni digitali e polemiche stagionali, il dibattito pubblico sulle spiagge sembra girare a vuoto. I titoli si rincorrono, denunciando la crisi degli stabilimenti balneari, l’eccesso dei prezzi, la miseria dei salari. Ma il cuore della questione non è se un lido guadagni abbastanza. È se sia legittimo che un bene collettivo venga gestito come fosse proprietà privata, in assenza di regole certe, in spregio al diritto universale all’accesso al mare. La spiaggia è demanio pubblico: lo stabilisce la Costituzione, lo confermano le leggi. È inalienabile, non può essere ceduta, né usucapita. Eppure, la maggior parte della costa è oggi sbarrata, controllata da privati che operano con regole proprie, mentre le istituzioni osservano in silenzio.
Le concessioni balneari, in teoria temporanee, sono tutte scadute. Il Consiglio di Stato ha chiarito che non esistono proroghe legittime dopo il 2023. Eppure, i lidi continuano ad aprire, a vendere posti, a sfruttare suolo pubblico senza alcun titolo valido. È un paradosso giuridico che si regge su un’omertà diffusa. Nessuno interviene, perché il sistema delle spiagge è diventato terreno di scambio politico, frammentato dalla gestione locale e piegato alla logica clientelare. In molte aree costiere, anche gli ultimi tratti di spiaggia libera sono scomparsi o sono diventati privatizzati di fatto, durante la pandemia, tra paletti “di sicurezza” trasformati in recinti commerciali. Oggi anche i venditori ambulanti impongono prenotazioni, montano strutture abusive, allontanano chi non consuma. Tutto avviene sotto gli occhi di tutti, senza controlli, senza sanzioni.
Le comunità costiere, che per tradizione vivevano il mare come parte della propria identità quotidiana, si ritrovano escluse dai luoghi che un tempo erano accessibili senza barriere. O si paga, o si litiga. E chi sceglie di resistere si trova costretto a denunciare, spesso invano. Gli esposti restano nei cassetti, la giustizia tace, lo Stato arretra. Lungo ogni tratto di costa si annida una struttura di interessi che mescola rendita, politica e potere locale. Chi prova a scardinarla viene isolato, deriso, ignorato.
A complicare tutto c’è un retaggio culturale che confonde il pubblico con il familiare. In Italia è accettato che l’attività di un genitore passi al figlio, anche se si basa su un bene comune. Anche nel caso delle concessioni, l’idea che siano trasmissibili come un’eredità resiste, nonostante sia contraria alla legge. Le concessioni non sono proprietà, sono autorizzazioni temporanee che devono essere affidate con procedure trasparenti. La loro trasmissione diretta è una distorsione profonda, che mina il principio di equità e favorisce privilegi consolidati. Quando si parla di spiagge, c’è chi minimizza: “Con tutti i problemi che abbiamo, pensiamo al mare?” Ma il mare è molto più di un luogo di svago. È un simbolo, una parte viva dell’identità nazionale. Difenderne l’accessibilità significa riaffermare il valore dei beni comuni,contrastare l’idea che tutto possa essere monetizzato, persino l’orizzonte.
Non si tratta però di demonizzare chi lavora negli stabilimenti. Molti gestori sono professionisti seri, che garantiscono servizi fondamentali come pulizia, bagnini, pronto soccorso. In tante località, senza il loro lavoro, le spiagge rischierebbero l’abbandono. Il problema emerge quando lo Stato abdica alle proprie funzioni e lascia il campo libero a un sistema senza controlli, dove i canoni sono irrisori, le regole inapplicate e gli abusi sistematici. Chi lavora onestamente dovrebbe essere il primo a chiedere regole chiare, eque, uguali per tutti. Ma finché non verranno
indette gare pubbliche, finché i canoni resteranno simbolici, finché i Comuni non saranno messi in condizione di gestire direttamente, con fondi propri o modelli cooperativi, i tratti di costa ancora liberi, ogni tentativo di riforma sarà ostacolato.
La riforma è urgente e deve essere coraggiosa. Serve introdurre gare aperte e trasparenti per tutte le concessioni, aggiornare i canoni secondo i reali valori di mercato, vincolare almeno la metà delle spiagge all’uso libero e garantire che anche quelle siano sicure, pulite, accessibili. Serve investire in servizi pubblici, finanziati proprio dai ricavi delle concessioni. E serve finalmente applicare controlli rigorosi, sanzionando gli abusi e interrompendo l’occupazione selvaggia del demanio. Ma soprattutto serve una cittadinanza informata e attenta, capace di difendere i diritti collettivi con responsabilità. Perché se la libertà si trasforma in disordine e degrado, si rischia di legittimare chi invoca la privatizzazione come unica soluzione.
Il mare non è solo una questione di ombrelloni e lettini. È una cartina al tornasole di come l’Italia gestisce i beni pubblici, tra retorica e realtà. La discussione sulle spiagge non può essere ridotta a una guerra tra “liberi” e “concessionari”, tra “turismo” e “giustizia sociale”. Va superata la falsa contrapposizione tra chi chiede legalità e chi teme di perdere il lavoro. È possibile, e necessario, trovare un equilibrio. Nessuno nega che il settore balneare sia un comparto economico importante. Ma proprio per questo va regolato con trasparenza, per evitare che pochi privilegiati continuino a guadagnare sfruttando ciò che appartiene a tutti.
Il nodo delle concessioni non può più essere rimandato. L’Italia ha avuto quindici anni per recepire la direttiva Bolkestein, che non chiede altro che un principio base in ogni democrazia: le concessioni pubbliche vanno affidate con gara, in modo aperto e giusto. E invece, al suo posto, si è scelto di temporeggiare, prorogare, ricorrere, confondere. In questa palude normativa si sono insinuati abusi, clientele, rendite di posizione. Così il mare, anziché un diritto, è diventato una concessione di fatto a chi ha più forza, economica o politica. E mentre lo Stato incassa cifre ridicole da concessioni che generano miliardi, la collettività paga il prezzo della propria esclusione.
Chi parla di riforma viene accusato di voler sabotare il turismo. In realtà, senza regole e giustizia, non si costruisce nulla che duri. Difendere l’accesso libero al mare non è un attacco all’impresa, è una difesa della democrazia. E se oggi siamo costretti a domandarci se avremo ancora una spiaggia libera dove andare, il vero fallimento non è della Bolkestein, ma nostro.

















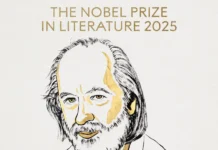









articolo chiaro, completamente condivisibile. Grazie!