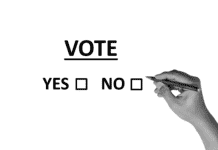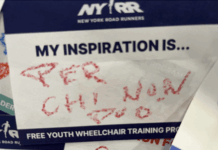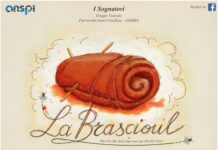«Vero o falso fa lo stesso. La realtà e la verità sono due cose diverse»
(Murakami Haruki, da “La città e le sue mura incerte”)
«Paragonando la Russia al Terzo Reich e scordandosi i 28 milioni di morti sacrificati dall’Urss per sconfiggere il Terzo Reich, Mattarella è riuscito nella mission impossible di far passare dalla parte della ragione la portavoce russa Zacharova. Geniale»
(Marco Travaglio, da “Il Fatto quotidiano” del 15.2.2025)
Premetto che il sintagma inglese FAKE NEWS non mi piace. Preferisco il buon vecchio termine “bufala”, quand’anche oggi rimandi, non tanto alla femmina del bufalo, ma alla mozzarella del latte della stessa femmina, o, al più, alla pizza ricoperta dallo stesso latticino.
E tuttavia, oggi, se vogliamo parlare di notizie false, e farci capire dalle nuove generazioni, non possiamo non ricorrere a fake news, quello che una volta si sarebbe detto “barbarismo”.
I giornali, sia cartacei che on line, che radiotelevisivi, sono pieni di notizie false, spesso non clamorosamente, ma che fanno del verosimile la loro cifra per ingannare il lettore o l’ascoltatore.
Che strumenti abbiamo per distinguere il falso dal vero?
I legislatori, nazionali e dell’UE, si sono ingegnati ad inventarsi figure “super partes” capaci di separare “il grano dal loglio”, anche imponendole alle redazioni dei giornali. Ma non si sono accorti che la strada è impervia pure per queste figure immaginifiche, che dovrebbero essere onniscienti per far bene il loro lavoro. Le stesse piattaforme “social” di recente ci hanno rinunciato ed è l’utente dell’informazione che dovrebbe essere avvertito talmente tanto da distinguere la notizia falsa da quella vera.
Ma non meravigliamoci più di tanto. Le bugie ce le hanno sempre raccontate e pieni ne sono i libri di storia.
Me ne vengono in mente tre, tutte legate al secolo scorso.
Ma analizziamole in ordine di tempo.
La prima riguarda la storia patria.
Siamo nel 1918. La eroica battaglia di Vittorio Veneto, che l’esercito italiano affronta coraggiosamente, vede la sconfitta definitiva dell’esercito austro-ungarico. È, in pratica, la fine della guerra. Evviva! Sipario.
Questo si trova sui libri di storia.
In realtà, più recenti ricerche (ma già Montanelli, storico mai abbastanza apprezzato, perché fuori di ogni accademia!) hanno dimostrato che a Vittorio Veneto non ci fu alcuna battaglia, semplicemente perché l’esercito asburgico già si era liquefatto ed era in rotta. Lo stesso Diaz, comandante in capo dell’esercito italiano che aveva sostituito l’imbelle Cadorna, avrebbe detto, in dialetto napoletano, cercando di trovare sulla cartina geografica il luogo dello “scontro” : “ma Vittorio Veneto addo’ c***o sta?”
Ma tant’è, la retorica patriottarda e nazionalista pretendeva il suo prezzo, anche per giustificare agli occhi di un popolo piegato da tre anni e mezzo di guerra, il massacro di un’intera generazione di uomini in quella che Benedetto XV aveva giustamente definito “inutile strage”.
La seconda riguarda la storia dello sport e non solo.
Siamo a Berlino nel 1936. Regna Hitler, acclamato dal suo popolo, e ci sono le olimpiadi.
Un nero americano, Jesse Owens, vince quattro medaglie d’oro: nei 100m, 200m, staffetta 4x100m e salto in lungo. Un rappresentante di una “razza inferiore”, quella “negroide” che manda all’aria tutte le teorie sulla supremazia della razza bianca sostenute dalla Germania nazista.
Hitler, sdegnato, per non dare la mano al vincitore, all’atto della consegna delle medaglie, si allontana dallo stadio.
In realtà, Hitler non dava mai la mano a nessuno, limitandosi a sollevare il braccio nel saluto nazista, e per complimentarsi con l’americano, gli inviò uno dei suoi quadri, perché il fuhrer si dilettava di pittura.
Quando Owens tornò in patria, Franklin Delano Roosevelt, presidente USA in carica e impegnato nella campagna elettorale per le elezioni di novembre di quell’anno, non lo ricevette alla Casa Bianca per non alienarsi le simpatie e i voti dei democratici e degli elettori razzisti del Sud. Ricordiamo, di passata, che negli USA di quegli anni vigeva, negli Stati del Sud, un severo apartheid.
La terza riguarda ancora gli Stati Uniti.
Siamo a Dallas, Texas, il 22 novembre 1963.
A mezzogiorno e mezza, Lee Harvey Oswald, dal sesto piano del Book School Depository, spara con un vecchio fucile, al presidente Kennedy, tre colpi, uccidendolo e ferendo un passante e il governatore Connolly. Il secondo proiettile, quasi animato di vita propria, fa un giro speciale nel corpo di JFK, esce, e, per soprammercato, ferisce il governatore. Il terzo fa saltare una parte del cranio del presidente.
Queste, almeno le conclusioni della commissione Warren, appositamente nominata. Fine della storia.
In realtà, già alla fine degli anni ’60, i dubbi sull’episodio, sono stati tanti. Aveva sparato solo Oswald? Come poteva il secondo proiettile aver avuto una traiettoria così contorta entrando e uscendo dal corpo del Presidente fino a fermare la sua corsa in quello del governatore?
Ci si chiese se Oswald avesse fatto tutto da solo o avesse dietro qualche mandante, tipo il mafioso Giancana, l’FBI o, si ipotizzò, lo stesso Johnson che subentrò a Kennedy, essendone il vice.
Trump ha dichiarato recentemente che vuole aprire gli archivi affinché sul caso Kennedy si arrivi alla verità.
La storia è revisionismo, o non è.
La cronaca deve avere nel lettore il dominus, capace di individuare eventuali inganni per non bersi tutte le fesserie che i media pubblicano. E questo è possibile solo se il lettore è persona istruita, colta, razionale e ragionante, qualità in disarmo e sempre più rare.