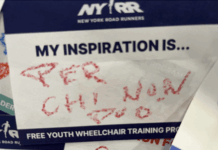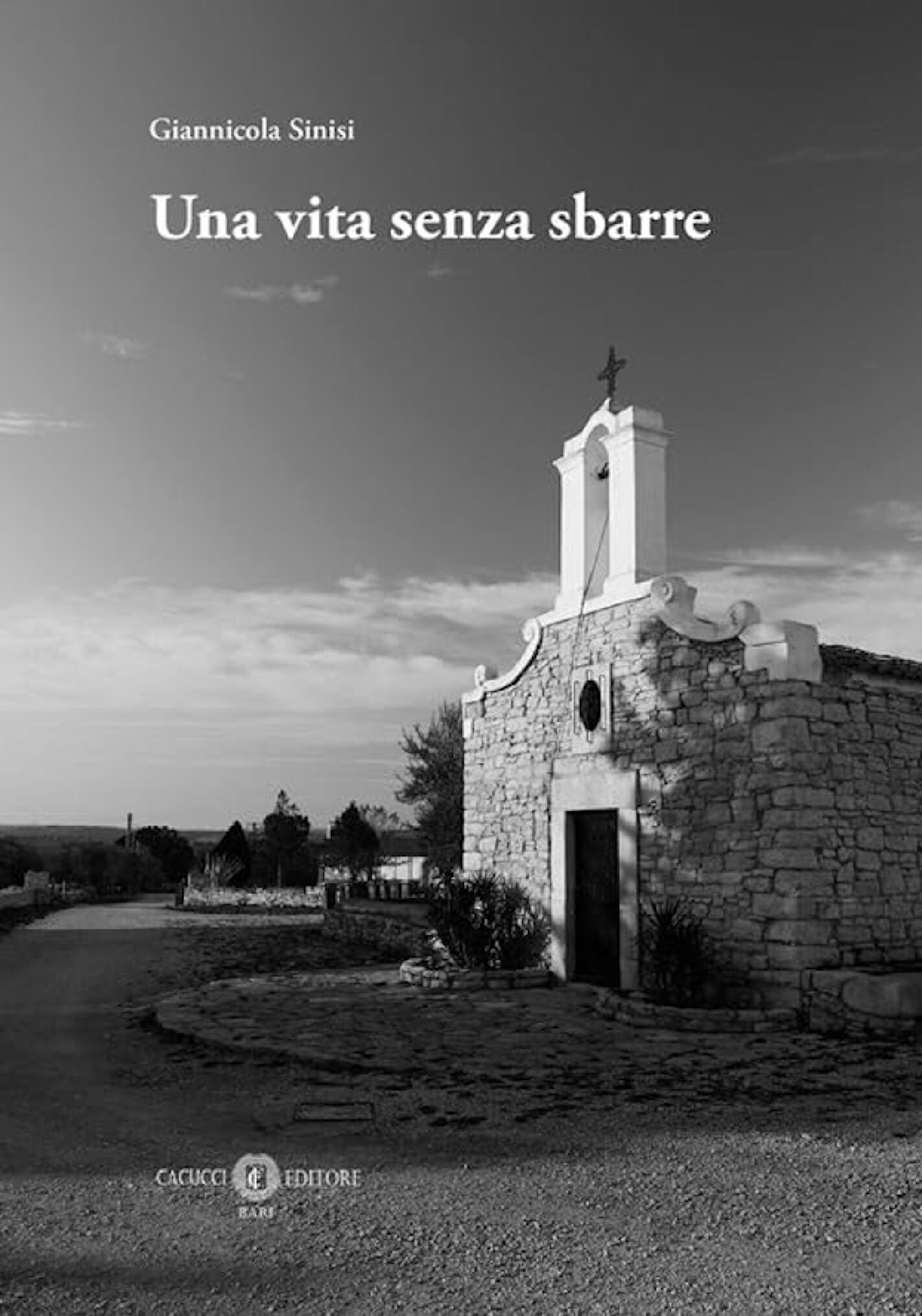«Dio ha creato le terre con i laghi e i fiumi perché l’uomo possa viverci. E il deserto affinché possa ritrovare la sua anima»
(Proverbio Tuareg)
Scrivo queste righe mentre attraverso il deserto meridionale della Giordania. Siamo partiti da Wadi Rum e ci dirigiamo verso il Mar Morto. Ieri abbiamo visitato Petra, il giorno prima Petra Piccola e, ancora prima, Jerash. Ho visto altre località che volutamente non nominerò: questo non vuole essere il resoconto di un viaggio turistico.
Vorrei piuttosto condividere pensieri che mi si agitano scomposti nel petto. Sono pervaso dal giallo ocra tendente al rosso di questa sabbia finissima, che mi riempie gli occhi — anche letteralmente, io che sono allergico alla polvere! — e da questo cielo blu cobalto che non smetto di contemplare, cercando di saturare la mia memoria visiva per portarne a casa almeno un fazzoletto.
Di fronte a tanta bellezza, affiorano storie che mi fanno riflettere e che non riesco a ordinare come vorrei. Le cito in ordine sparso: un popolo, quello giordano, ospitale al punto che i cittadini giordani sono ormai minoranza rispetto ai profughi accolti da mezzo mondo — palestinesi, siriani, e altri ancora. Un popolo considerato “la Svizzera del Medio Oriente”, che paga la sua stabilità ospitando basi militari statunitensi e campi profughi che somigliano più a campi di concentramento. Un popolo legato alle sue tradizioni beduine e alla nobile storia nabatea, ma che ha visto, in poco più di un secolo, metà della sua popolazione concentrarsi ad Amman: una città senza centro storico, senza parchi, senza zone pedonali, un agglomerato informe di case sorte per lo più senza piano regolatore.
Un popolo, insomma, difficile da inquadrare, diviso tra le tentazioni mefistofeliche della modernità — è possibile pagare con carta di credito persino su sentieri sperduti nel deserto, in omaggio al dio capitalista! — e tradizioni ancora vive, in cui il maschilismo convive con un matriarcato sorprendente: in molte tribù è la madre a scegliere la sposa per il figlio, combinando il matrimonio tra cugini di primo grado. E dove la legge beduina impone ancora oggi che il sangue venga pagato col sangue, in ossequio alla mai tramontata legge del Taglione.
In questo maremoto di pensieri, mi torna alla mente la voce della mia guida: «I beduini amano la libertà, non potrebbero vivere in una casa. Hanno bisogno degli spazi aperti e del silenzio del deserto per sentirsi liberi».
Sto attraversando proprio quel loro spazio di silenzio e libertà: mi affascina e mi intimorisce allo stesso tempo. Mi affascina e spaventa percepire la voce del deserto, la forza senza riguardi del suo vento, i suoi raggi solari, asciutti e impietosi, le sue distese di solitudine. Mi chiedo se sarei mai capace di sopravvivere in simili condizioni. Temo che la mia risposta sarebbe un secco no. E immagino che, a parti invertite, anche loro risponderebbero allo stesso modo se li invitassi a vivere nelle nostre città rumorose, congestionate dal traffico e soffocate dallo smog. No, penso proprio che direbbero: «Grazie, ma no, grazie!» (ciao, Willie, fratello granata!), tanto più se spiegassi loro i ritmi assurdi e irrefrenabili della nostra quotidianità.
E mi torna ancora la voce della mia guida giordana: «Il giordano non ha fretta, il giordano fa le cose con calma». Ecco, appunto: il giordano ama i tempi del deserto. E nel deserto non si può correre. Si avanza lentamente, un passo alla volta, mentre i piedi pesanti affondano nella sabbia. Ma si avanza. Oppur si muore.
Dal film Lawrence d’Arabia «Lawrence, solo due tipi di esseri si trovano bene nel deserto: i beduini e gli dei. E lei non è fra questi».
Bruce Chatwin: «Chi percorre il deserto scopre in se stesso una calma primitiva […] che è forse la stessa cosa della Pace di Dio».
Proverbio Tuareg: «Se hai una meta, anche il deserto diventa una strada».