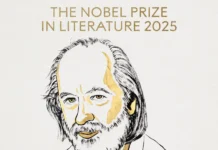È il risultato di un’educazione che mi ha sottratto la possibilità di diventare me stesso
È più facile parlare di fragilità, più difficile riconoscersi nella mancanza di strumenti. Eppure nel linguaggio pubblico, genitori, educatori, psicologi, media, quella parola, “fragilità”, viene ripetuta ossessivamente come un marchio, una gentile etichetta. Innanzitutto, la parola serve a etichettare, a spostare la responsabilità, a trasformare in colpa individuale ciò che è, invece, il risultato di scelte collettive e familiari. Se mi trovo davanti alla mia vita incapace di affrontarla, incapace persino di reggermi in piedi, questo non significa che io sia fragile: significa che qualcuno, nel momento in cui aveva il dovere di farlo, non mi ha dato gli strumenti necessari, non mi ha insegnato ad affrontare il dolore, perché aveva troppa paura che sbagliassi. Così, mi ha assistito nei compiti, togliendomi la possibilità di fallire e di imparare dal fallimento. Mi ha impedito di cadere, togliendomi lo stupore del magnifico mistero di una ferita che si rimargina. Ha fortificato la casa, metaforicamente, per paura che uscissi, tracciando al mio posto le mappe del mondo e insegnandomi che le mie mappe personali sono inaccettabili. Mi ha fatto credere che solo in famiglia si è davvero amati, creando diffidenza, indifferenza o dolorose distanze verso i miei coetanei. Ha demonizzato la scuola, il lavoro, la società, ma senza muovere un dito per cambiarli, trasmettendomi così l’idea che la passività è l’unica posizione possibile. Mi ha rubato le prime esperienze, il primo bacio, il primo San Valentino, il primo concerto, il primo segreto custodito in silenzio, appropriandosi della mia vita emotiva. Mi ha trasformato in un oggetto che vive in funzione di un soggetto, e adesso, quando sono solo, la mia incompletezza mi devasta. E tutto quello che mi si offre in cambio sono etichette da appiccicarmi addosso per fingere identità o per guarirmi da una malattia che non ho.
Davanti a uno specchio, stordito dal benessere materiale e dalla passività in cui sono stato costretto, mi chiedo chi sono. Chi avrebbe dovuto fornirmi gli strumenti adeguati per capirlo mi dice che sono fragile, organizza convegni sulla fragilità, coinvolge psicologi e pedagogisti per discutere del “problema dei giovani fragili”. Ma il problema non siamo noi. Io, dentro di me, lo so, lo sento che c’è qualcosa di sbagliato, sento la gabbia. Capisco che non è amore, ma controllo; tutto questo non è protezione, ma sottrazione. Non ho avuto il tempo né il modo di cercare parole mie per dirlo, perché qualcun altro ha scritto la mia storia fin da quando sono nato, relegandomi a personaggio secondario della mia stessa esistenza. Eppure, in mezzo a questa angoscia, io so anche di cosa ho bisogno: spazio, tantissimo spazio. Ho bisogno di Silenzio, molto silenzio, dell’amore giovane dei miei coetanei, delle ferite che sanguinano e poi guariscono. Vorrei esperienze che siano davvero mie, anche sbagliate, anche dolorose.
Non so da dove cominciare perché nessuno me lo ha insegnato. Nessuno mi ha mostrato come vivere fuori dalla gabbia. E chi aveva il dovere di farlo oggi mi incolpa, si chiede perché io non sia felice, perché pianga per un voto, perché scelga l’autolesionismo invece di reagire. Mi dice che mi amerà “così come sono”. Ma il fatto è che io non so come sono. Mi perdo nell’angoscia di non avere altra forma che quella che mi è stata imposta.
Non è fragilità. Per lo meno, non la mia. È il risultato di un’educazione che mi ha sottratto la possibilità di diventare me stesso, che mi ha imposto percorsi e mappe già tracciate, un futuro anteriore scritto da altri. James Hillman lo dice chiaramente: “Mentre procedi, un passo dopo l’altro, attraverso una mappa già tutta disegnata, ti ritrovi su un itinerario che ti dice dove sei stato prima ancora che tu ci sia arrivato. Il corso della tua vita è stato descritto dal futuro anteriore.”Ecco: io sono qui, su quella mappa. Ma la mia forza non sta nel seguire il percorso che mi è stato dato, bensì nel tentativo di strapparla, riscriverla, rischiare. Non è fragilità. È mancanza di strumenti. È deprivazione di autonomia. È una colpa adulta, non un difetto infantile. Il problema non siamo noi: il problema è un mondo adulto che, invece di farsi da parte e insegnare la libertà, continua a gestire, controllare, assorbire, per poi meravigliarsi che noi, messi davanti alla vita, non sappiamo reggerci in piedi. L’unico modo per uscire da questa spirale non è continuare a parlare di fragilità ma riconoscere l’errore, restituire spazio, restituire errori, restituire privacy, restituire possibilità. Solo così potremo smettere di essere personaggi secondari della nostra esistenza e tornare, finalmente, ad esserne gli autori.
“(io adulta consapevole, ti chiedo scusa)”.