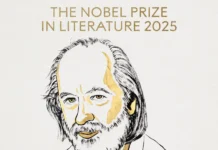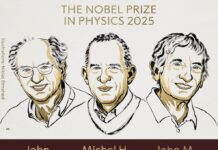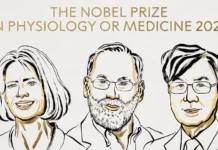Caro Bertolt,
ti scrivo da un tempo che avresti riconosciuto. Non per le strade, né per le bandiere ma per l’odore. L’odore della menzogna ben confezionata, del potere che si fa gentile mentre strangola. Hai visto il fascismo travestirsi da ordine, oggi vedresti la democrazia mascherata da algoritmo.
Le elezioni nella nostra epoca si vincono con i dati, non con le idee. La rivoluzione non urla più dalle piazze, suggerisce dagli smartphone.
Hai attraversato le macerie della Repubblica di Weimar. Hai visto il fascismo crescere nutrito e protetto dagli agi della borghesia. Hai lasciato Berlino mentre il fuoco della propaganda bruciava i libri e, più facilmente della carta, le coscienze.
Hai vissuto l’esilio in Danimarca, in Finlandia e negli Stati Uniti. L’Europa si sbriciolava sotto le bombe e sotto le ideologie. Hai visto il Terzo Reich trasformare il teatro in strumento di infodemia e per opposizione hai trasformato il teatro in strumento di pensiero. Il potere si vestiva di croci uncinate e il popolo applaudiva la sua stessa condanna. I poeti morivano in silenzio e i generali chiacchieravano troppo.
Nel 1933, Hitler saliva al potere, e tu scrivevi La misura e La resistibile ascesa di Arturo Ui. La morale? Il male non è inevitabile e la storia non è una tragedia greca ma una commedia di vita che possiamo riscrivere.
Hai ricordato Galileo non per raccontare la scienza ma per denunciare la viltà servile degli intellettuali di fronte al potere: lo hai messo sotto processo e noi abbiamo applaudito.
Hai scritto Madre Courage durante la Seconda Guerra Mondiale: il mondo si divideva tra vincitori e vinti e per te, disilluso, la guerra non poteva essere una vittoria per chi vendeva il pane e i figli.
Nel dopoguerra sei tornato in Germania: il socialismo prometteva giustizia ma spesso offriva una comoda censura. Hai fondato il Berliner Ensemble non per celebrare il regime ma per continuare a porre domande scomode.
Il mondo è ancora una farsa. I padroni hanno cambiato nome ma il guinzaglio è lo stesso.
Hai tolto il sipario non solo dal palco ma dagli occhi del pubblico. Un attaccapanni può diventare un albero come la fede può diventare la casa del Padre. Il protagonista è l’essere umano che non comprende e non è compreso. L’attesa e l’assenza diventano presenze invisibili che inquietano.
Hai fatto della scena un luogo di lotta in cui il pensiero è più importante dell’emozione, in cui il dubbio è più prezioso della certezza. Cambiare il mondo, dicevi, non è un atto poetico, ma necessario. L’uomo non è buono né cattivo ma plasmato dalle condizioni in cui vive.
Il pubblico deve soprattutto pensare. L’arte non è un rifugio ma un campo di battaglia. Ma oggi il pubblico vuole dormire. Vuole ridere. Vuole dimenticare.
Il tuo teatro era un grido e oggi abbiamo solo sussurri. Senza di te il sipario non cala. Ci soffoca.
Dalla guerra in Ucraina, dalla tragedia di Gaza, dalle frontiere chiuse, a chi scappa dalla fame e dalla morte. Il mondo è ancora diviso, solo che ora lo chiamiamo geopolitica.
La scienza è piegata al profitto e chi denuncia viene licenziato, non processato.
Con gratitudine e inquietudine, un figlio del tuo teatro.