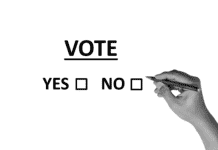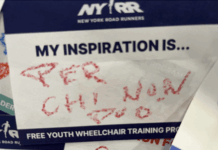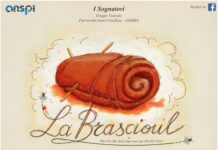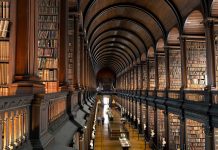Tra legge e realtà
In un mondo in cui l’uguaglianza di genere resta ancora un obiettivo più che una realtà, Italia e Cuba rappresentano due percorsi distinti ma intrecciati nella loro storia legislativa, segnati entrambi da un lungo dominio patriarcale e da riforme che, seppur fondamentali, giungono spesso in ritardo rispetto ai cambiamenti sociali. Le trasformazioni normative in materia di diritti delle donne, violenza di genere e uguaglianza familiare sono state lente, frammentarie e, in molti casi, più conseguenza di pressioni sociali e culturali che di una volontà politica coerente.
In Italia, la parità di genere è sancita fin dal 1948 dalla Costituzione, ma il riconoscimento concreto dei diritti delle donne è stato ostacolato per decenni da leggi che tutelavano l’onore familiare più che l’integrità fisica e morale delle vittime. Emblematica è la norma del matrimonio riparatore, prevista dall’articolo 544 del codice penale fino al 1981, che consentiva allo stupratore di estinguere il reato sposando la vittima, in nome di una morale che vedeva nella violenza sessuale una macchia sull’onore familiare e non un crimine contro la persona. Il delitto d’onore, previsto fino allo stesso anno dall’articolo 587 del Codice Rocco, riduceva drasticamente le pene per chi uccideva una donna “colta in flagrante adulterio”, confermando la supremazia maschile nel controllo sociale e giuridico delle relazioni familiari.
Questi istituti giuridici sono stati aboliti solo a seguito di pressioni culturali e mediatiche, come il celebre caso di Franca Viola, la giovane siciliana che nel 1966 si oppose pubblicamente al matrimonio con il proprio stupratore, diventando un simbolo della lotta per la dignità e l’autodeterminazione femminile. Solo nel 1996 la violenza sessuale è stata riconosciuta come reato contro la persona, e non più contro la morale pubblica. Le riforme più recenti, come il Codice Rosso del 2019 e la legge 168 del 2023, hanno introdotto misure più rapide e severe contro la violenza domestica e sessuale, ma restano forti le criticità legate alla prevenzione, alla protezione delle vittime e alla formazione degli operatori. La ratifica della Convenzione di Istanbul nel 2013 ha rafforzato il quadro normativo, ma la sua attuazione pratica è spesso ostacolata da disuguaglianze territoriali e da una persistente cultura della minimizzazione della violenza.
Cuba, pur con un sistema politico e giuridico molto diverso, ha attraversato un percorso parallelo. La sua nuova Costituzione del 2019 sancisce l’uguaglianza di diritti tra donne e uomini e impegna lo Stato nella prevenzione della violenza di genere. Tuttavia, anche sull’isola caraibica, il peso di una cultura patriarcale radicata ha ritardato l’effettiva protezione delle donne. Negli anni ’80 e ’90, le forze dell’ordine proponevano spesso il matrimonio riparatore come soluzione extragiudiziale a casi di violenza sessuale contro minorenni sopra i 14 anni. La percezione della violenza come offesa all’onore, piuttosto che come crimine personale, rifletteva una visione ancora machista e familista della giustizia.
Una svolta importante è arrivata nel 2022, con l’approvazione tramite referendum popolare del nuovo Codice delle Famiglie, che ha ottenuto il sostegno del 66% degli elettori. Questo testo sostituisce l’obsoleto codice del 1975 e introduce una serie di novità che segnano un cambiamento significativo: il riconoscimento del matrimonio e dell’adozione per le coppie dello stesso sesso, la regolamentazione della gestazione per altri in contesti altruistici, il riconoscimento della violenza di genere, il diritto alla cura condivisa e l’introduzione di meccanismi legali per contrastare abusi e maltrattamenti in ambito familiare. È un progresso notevole per una società in cui le donne hanno avuto un ruolo fondamentale nella costruzione dello Stato socialista, ma dove la cultura machista ha continuato a esercitare un’influenza profonda, anche nelle istituzioni. Tuttavia, come in Italia, anche a Cuba il salto dalla norma alla realtà resta complesso, manca ancora una tipizzazione specifica del femminicidio nel Codice penale, e l’assenza di dati ufficiali aggiornati e trasparenti rende difficile monitorare l’impatto delle politiche pubbliche. Inoltre, in un contesto dove la società civile è fortemente controllata e l’informazione è centralizzata, le possibilità di attivismo e denuncia restano limitate, e le trasformazioni culturali rischiano di essere più di facciata che sostanziali.
Il confronto tra i due paesi mostra come le conquiste legislative siano necessarie, ma non sufficienti. Le leggi possono rompere il silenzio e creare nuovi paradigmi di giustizia, ma solo l’educazione, la consapevolezza sociale e l’azione collettiva possono trasformare quei principi in pratiche quotidiane. In Italia, la battaglia per una giustizia realmente femminista si gioca oggi sulla prevenzione, sulla formazione, sulla riforma delle istituzioni e sulla tutela effettiva delle vittime. A Cuba, la sfida consiste nel fare in modo che le nuove norme diventino strumenti reali di emancipazione in una società ancora attraversata da disuguaglianze strutturali e culturali.
In definitiva, se le traiettorie storiche e politiche divergono, la domanda di fondo è la stessa: quanto può il diritto incidere sulla cultura? E quanto può la cultura frenare o accelerare il cambiamento giuridico? In entrambi i paesi, il futuro della parità di genere dipenderà dalla capacità di colmare questa distanza, mettendo al centro non solo la norma, ma anche la vita delle donne.