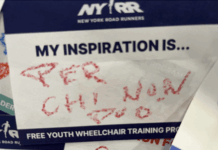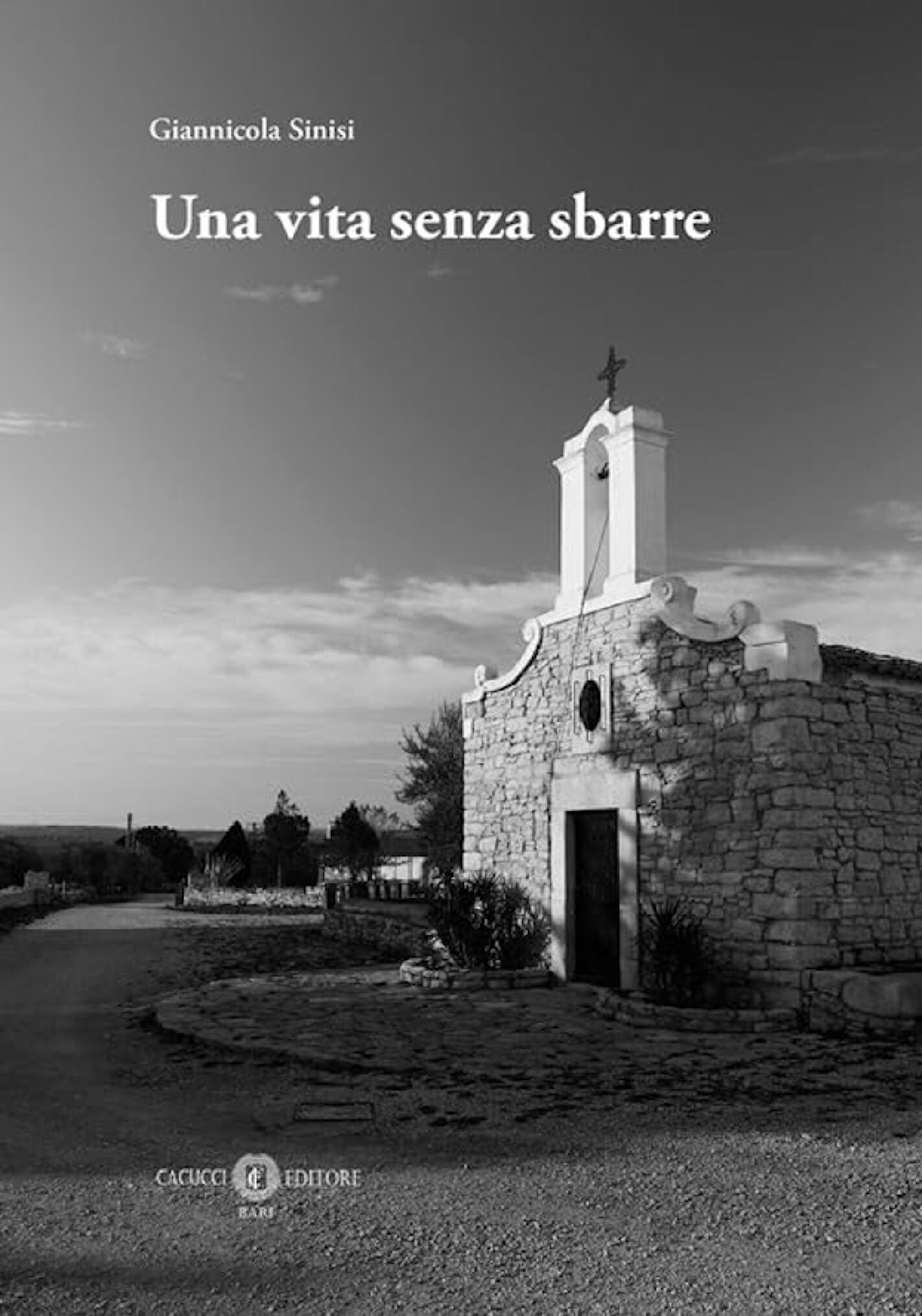Una riflessione sul rispetto, l’immagine e le relazioni nell’epoca digitale
In un mondo sempre più abituato a consumare corpi come contenuti, l’indignazione morale davanti a episodi di abuso di immagine o di violazione del consenso rischia di diventare solo un automatismo passeggero, svuotato del pensiero critico. È accaduto anche di recente, con la triste vicenda della pagina “Mia moglie”, un caso che ha scatenato un’ondata di condanne, ma che sembra essere stato già assorbito e dimenticato dagli algoritmi. Eppure ciò che resta, ciò che dovrebbe restare, è lo sforzo di interrogarsi più a fondo: perché siamo arrivati a questo punto? Che rapporto abbiamo davvero con il corpo, nostro e altrui?
Viviamo in un’epoca in cui è normale frammentare sé stessi per piacere, visibilità o denaro. Si vendono porzioni di corpo su piattaforme legali, si affittano ventri ignorando la persona che li abita, si condividono immagini intime come pegno d’amore. È un sistema trasversale, che coinvolge uomini e donne, celebrità e persone comuni, etero e LGBTQ+, in una spirale di esposizione che non conosce più confini. Anche l’estetica si piega a questa logica: il costume da bagno che copre davvero le natiche è ormai una rarità, anche per le bambine. Sui social, è una corsa alla posa perfetta per valorizzare un dettaglio, un taglio, una curva. E dietro ogni frammento, c’è una storia che viene ignorata. È qui che s’incrina l’illusione del gesto “consensuale”. Perché, se da un lato mostrare un pezzo di corpo può essere un atto deliberato, dall’altro gli effetti collettivi di questa esposizione superano le intenzioni individuali. Chi guarda, spesso, non si ferma al rispetto dell’identità intera, ma consuma l’immagine come se fosse un prodotto, un bene da interpretare a piacere. Così, il corpo diventa uno spazio espropriato, disgiunto dalla persona. E quando le relazioni affettive si costruiscono su queste basi fatte di immagini, proiezioni, accessi parziali, si genera una cultura in cui la fiducia si infrange facilmente, l’intimità si riduce a consumo e il rispetto si sgretola.
La questione non è soltanto sessuale o morale, ma è culturale. Una società che tratta i corpi come frammenti da vendere o da decorare perde la capacità di ascoltare la totalità dell’altro. L’intimità diventa un servizio, il desiderio un catalogo, l’identità un profilo. Si vive dentro relazioni inquinate da aspettative irrealistiche, da confronti continui, da immagini idealizzate e mercificate. Si scambia il controllo per amore, il possesso per intimità. E in questo contesto, anche i concetti di relazione tossica, abuso, sfiducia, diventano più sfumati, meno riconoscibili, ma non per questo meno devastanti. Questa cultura del corpo a pezzi non nasce dal nulla. È il risultato di valori distorti, di una gerarchia silenziosa che da sempre mette il femminile in secondo piano. Ancora oggi, anche nei contesti in apparenza più emancipati, le attività considerate “da donna” vengono relegate in una zona d’ombra. Sport come la ginnastica artistica, le professioni di cura, le materie umanistiche, tutte aree di eccellenza, ricevono una visibilità minima, spesso in bassa risoluzione. Mentre il maschile continua a essere il parametro del successo, del potere, della visibilità, il femminile resta un contorno, un’estetica da apprezzare solo se conforme.
In questo clima, non sorprende che anche la violenza venga spesso narrata male. Si parla di femminicidi senza parlare di educazione, si condanna l’uomo violento senza interrogarsi sulla cultura che lo ha reso tale. Peggio ancora, si tace il ruolo delle donne che perpetuano i ruoli tradizionali, che educano alla sottomissione, che difendono la Bestia perché credono che sia “normale” che un uomo sia così. Questa complicità silenziosa, fatta di gesti quotidiani, di colori scelti per i figli, di parole pronunciate in casa o a scuola, alimenta una visione antiquata del mondo. E questa visione si riflette ovunque: nelle app, nei libri di testo, nei ruoli familiari. Il corpo, allora, diventa il primo luogo dove si consuma questa distorsione. Ma può essere anche il primo luogo da cui ripartire. Non più come superficie da offrire, ma come spazio da abitare pienamente. Non più solo immagine, ma simbolo della totalità della persona. È lì che si gioca la possibilità di costruire relazioni sane, autentiche, non tossiche. Relazioni in cui il rispetto non è un’aggiunta, ma la condizione di partenza. Relazioni in cui il corpo non è uno strumento, ma una presenza. Dove l’amore non si misura in foto mandate o richieste, ma in ascolto, pazienza e cura.
Cambiare lo sguardo è possibile, ma richiede un atto collettivo. Serve riconoscere la ferita culturale che ci portiamo dietro, smontare i modelli che abbiamo interiorizzato, e rifiutare l’idea che la libertà coincida con la mercificazione. Significa restituire valore alla complessità, alla lentezza, all’attesa. Perché ogni volta che un corpo viene ridotto a pezzo, un frammento di umanità va perso, e ogni volta che scegliamo di vederlo intero, contribuiamo, silenziosamente, a cambiare il mondo.