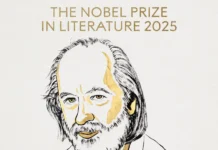Dovremo attendere che siano gli storici, che sia una Corte internazionale, a dirci, tra qualche anno, che a Gaza si è di nuovo perpetrato un eccidio, un crimine, un genocidio?
È un arduo privilegio avere amici provenienti da parti del mondo che sono teatro di guerre: devastate dalla povertà, dalla fame, da indicibili sofferenze. Informati quasi in diretta sulle loro tragedie, non si può essere solamente spettatori. L’empatia, l’amicizia sono un inesausto pungolo alla comprensione: la dobbiamo a noi stessi, ai nostri amici, ai loro popoli.
Per dire ciò che sta avvenendo in questo momento a Gaza – le uccisioni, le mutilazioni, la fame, che colpiscono soprattutto i civili, i vecchi, le donne e i bambini, le distruzioni di case, di scuole, di ospedali – non abbiamo né parole adeguate, né parole condivise. Parliamo di massacri, di eccidi, di pulizia etnica, di crimini di guerra… C’è un termine, che fluttua nel fondo della mente di molti, un termine che pochi hanno il coraggio di pronunciare. Questo termine è genocidio: se qualcuno lo pronuncia, è subito tacciato di antisemitismo. Anna Foa, cui il coraggio non le fa difetto, scrive: «Cosa cambia per chi muore sotto le bombe se definiamo la sua morte “massacro” o “genocidio”? Le distinzioni verranno dopo, nei processi, che speriamo ci siano, delle Corti internazionali» (Il suicidio di Israele, p. 54). Ha ragione, ma se pronunciare quella parola servisse a scongiurare il peggio? A metterci in allerta, e a mettere in allerta la Corte, perché sia più vigile, intervenga, freni, prevenga?
A usare la parola genocidio, in un certo senso, paradossalmente, è proprio un ebreo ad autorizzarci, e non da oggi: un giurista ebreo, Raphael Lemkin, che, mentre il processo di sterminio degli Ebrei in Europa era ancora in atto, creò il termine genocidio, facendone una figura giuridica atta a riconoscere e condannare un crimine che si configurava come sistematica e intenzionale distruzione di gruppi etnici, razziali o religiosi. Un crimine che, per dimensioni e inaudita ferocia, ancora non aveva un nome.
Raphael Lemkin, nasce il 24 giugno 1900 a Wolkowysk, una cittadina che oggi appartiene alla Bielorussia, ma in quegli anni era ancora parte dell’impero russo. Una terra di confine, in cui erano confluite minoranze lituane, ucraine, svedesi, diverse per lingua, tradizioni, religioni, ma tutte soggette a periodiche vessazioni, angherie, pogrom… La famiglia di Raphael, a dispetto della proibizione fatta agli Ebrei di praticare l’agricoltura, possiede una piccola fattoria, dove egli trascorre gli anni della fanciullezza. Il dialogo con la madre insegnante e le prime letture – lo rammenterà nelle memorie inedite – hanno come frequente argomento la storia di popoli e di civiltà annientate. Sopra il suo letto, il ritratto di Bartolomé de Las Casas: un dettaglio o una premonizione? La curiosità, la voglia di capire il mondo che gli sta intorno, dove vivono culture diverse, periodicamente sconvolte da violenze che hanno le comunità ebraiche come bersaglio privilegiato, lo orientano verso lo studio delle lingue – nel tempo riuscirà a parlarne sei e comprenderne fino a dodici –, un prezioso atout per le sue indagini. Presto però saranno gli studi giuridici ad avere il sopravvento: all’Università di Leopoli si laureerà in queste discipline, che gli permetteranno di unire conoscenza e azione, competenza e impegno.
Forte di queste conoscenze e di una volontà che non demorde, comincia ad agire nelle sedi istituzionali, nell’insegnamento universitario, partecipando ad incontri nei quali si discutono progetti di legge per far fronte a un mondo che si va sempre più disgregando, dove a farne le spese sono i gruppi etnici, razziali e religiosi, destinati ad essere vittime delle mire imperiali delle grandi nazioni. Già a partire dal 1933 denuncia lo stravolgimento del diritto attuato da Hitler che, nel Mein Kampf, aveva esposto il suo folle disegno. Quando i nazisti invadono la Polonia, impossibilitato ad agire apertamente, ma deciso a continuare la sua opera di informazione e di denuncia, Lemkin lascia a malincuore la famiglia, che successivamente verrà assassinata, e con una fuga rocambolesca attraverso i territori occupati dalle armate naziste raggiunge la Svezia dove, ina attesa del visto per l’America, apprende in poco tempo la lingua e tiene conferenze nell’Università di Stoccolma.
Durante la fuga e nel soggiorno in Svezia raccoglie una mole sterminata di documenti che, sistemati, confluiranno successivamente nella opera capitale, Axis Rule in Occupied Europe (Il potere dell’Asse nell’Europa occupata), un volume che nell’edizione a stampa del dicembre 1944 occuperà più di settecento pagine nelle quali, per la mostruosità storica assunta, avrà un ruolo centrale quello che successivamente sarà chiamato il «genocidio degli Ebrei». In America, grazie alla stima e all’autorità conseguita presso giuristi e uomini politici, ricopre incarichi universitari ed istituzionali, moltiplica i colloqui, incontra il presidente Roosevelt, a cui espone le sue preoccupazioni ed illustra i piani di annientamenti messi in atto da Hitler. Piani, per altro, già conosciuti dai governi inglese e americano e dagli stessi Ebrei d’America, costretti al silenzio per opportunità politica. Non si dà per vinto, continua la sua lotta, pubblica articoli sui principali quotidiani. Infine, amareggiato, capisce che la sua battaglia potrà farsi più intensa solo a guerra terminata, quando lo sterminio degli Ebrei sarà stato ormai perpetrato.
Nella solitudine degli ultimi anni (morirà il 24 agosto 1959) , Lemkin comincia la stesura della sua autobiografia. Leggiamone qualche frammento:
«Ero convinto che la missione fondamentale della mia vita doveva essere quella di realizzare una legge tra le Nazioni per proteggere i gruppi nazionali, razziali, religiosi dalla distruzione. Per proteggere gli innocenti ho creato nella mia testa una reazione a catena che mi ha accompagnato tutta la vita quando ho capito che la distruzione dei gruppi umani doveva esser considerata un crimine. Non ho mai smesso di pensarci così ho coniato la parola genocidio, un’espressione che dapprima adoperavo per uso personale ma che poi ho trasformato nell’argomento di un trattato internazionale. Ora che 41 parlamenti hanno accettato questa legge, sono grato alla Provvidenza per avermi scelto come messaggero di un’idea che avrebbe potuto salvare delle vite, […] una legge sovrannazionale che impedisse il ripetersi di ogni crimine contro l’umanità e di ogni genocidio».
Raphael Lemkin è un ebreo, un giurista, ha il suo nome nel “Giardino dei giusti” perché ha descritto minutamente tutte le fasi dell’annientamento degli Ebrei, ma la sua battaglia va oltre il loro «genocidio». Egli non ha mai pensato, e i suoi scritti lo testimoniano, di riservare a loro soltanto questo triste primato, non ha mai voluto opporre un crimine contro l’umanità ad un altro, un massacro a un altro, un genocidio a un altro. Le sue lucide analisi, già recepite dalla pubblica accusa durante il processo di Norimberga, il 9 dicembre 1948 hanno ispirato la «Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio», entrata in vigore il 12 gennaio 1951.
Purtroppo i crimini di genocidio, anche dopo la morte di Lemkin, si sono susseguiti in Cina, in Cambogia, in Tibet, in Rwanda e, più vicino a noi, nella ex-Yugoslavia e in Cecenia. Il quarto di secolo che abbiamo già vissuto non è stato da meno. Negli appunti e nella documentazione raccolta nel corso di tutta la sua vita, e nell’autobiografia di cui abbiamo letto un assaggio, Lemkin non si stanca di ripetere che genocidio è sì un termine nuovo, ma il male che descrive e che vorrebbe con tutte le forze prevenire è vecchio quanto l’umanità. L’unica, magra consolazione riservata a un’Europa e a un Occidente spettatori pavidi e imbelli, è forse questa? Attendere che siano gli storici, che sia una Corte internazionale, a dirci, tra qualche anno, che a Gaza si è di nuovo perpetrato un eccidio, un crimine, un genocidio.
Ps. Per saperne di più su un argomento complesso qui solo sfiorato, si può leggere Marcello Flores, Il genocidio, Il Mulino, 2021. Il mio amico Jean-Louis Panné, ha curato Qu’est-ce qu’un génocide? (Che cos’è un genocidio? ), Rocher, 2008, che è insieme una biografia appassionata e una antologia essenziale degli scritti di Raphael Lemkin. L’ho sfilato dal ripiano alto della libreria, l’ho riletto in questi giorni colpevoli, e gliene sono grato.