
25 novembre: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Parlare di violenza è ancora necessario.
Parlare di violenza di genere è ancora necessario e, al contempo, difficile, talvolta arduo.
Non si capisce fino in fondo cosa sia. Non si comprende che parlarne solo di fronte al femminicidio non basta. Non ci si convince che quella è la punta di un iceberg sommerso e silente, sopito almeno quanto una coscienza collettiva che fatica a riemergere dai propri stereotipi. Oltre che dalle proprie radicate, tossiche pedagogie e abitudini.
Si sente ancora parlare di schiaffi educativi e di umiliazioni che fanno crescere.
Si sente ancora chiedere ai ragazzi di essere “uomini”.
Si sente ancora ripetere alle ragazze che vanno male in matematica perché il loro cervello è “troppo emotivo”. Con buona pace delle indagini statistiche, stupite e stupefacenti, sul calo di iscrizioni femminili alle facoltà STEM. Come se le parole non pesassero, fino a diventare scelte, destini.
Si sente ancora dire che “è così perché lo dico io” e che “quando arriverai alla mia età capirai”.
E poi ci sono i silenzi punitivi o i drastici cambi di atteggiamento, solo perché si è stati contraddetti, solo perché si è ricevuta una delle forme di carità più alte che esistano: la sincerità. Non quella spiattellata in faccia senza modo e come verità assoluta (che pure è cosa da violenti), ma quella offerta con assertività rispettosa.
Si fatica a riconoscere in tutto questo un apporto non indifferente, spesso inconsapevole ma non per questo meno grave, a una generale cultura della violenza, in cui l’aggressività, ereditata da australopitechi lontani e vicini, non è educata a trasformarsi. È temuta, giudicata, repressa. E si inserisce in un circolo vizioso difficile da interrompere, da convertire in un ciclo virtuoso che inauguri cose nuove e destini diversi.
Il punto è questo: scattare, urlare, sparire, mutarsi di fronte a una divergenza di opinione non è normale. La trappola è considerare il dissenso una sfida letale al proprio sé. Ma educare al consenso significa, anzitutto, educarsi al dissenso. Perché, se vogliamo una società diversa, se vogliamo davvero estirpare la violenza di genere, dobbiamo allargare gli orizzonti e riflettere su qualsiasi tipo di abuso di potere in grado di alimentare la cultura dell’accordo forzato.
L’etimologia di “consenso” deriva dal latino consensus, participio passato del verbo consentire, che è composto da cum, “insieme” e sentire, “sentire”, “percepire”. Letteralmente, significa quindi “sentire insieme” e indica un accordo di pensieri, emozioni, sentimenti tra persone. “Dissenso”, invece, esprime esattamente il contrario: quel dis racconta, infatti, separazione, distanza, disaccordo. Certo, non è un mistero quanto sia difficile andare d’accordo con chi è in disaccordo con noi, specie su questioni di cruciale e vitale importanza. Tuttavia, esiste un accordo in grado di custodire il disaccordo? Un consenso capace di proteggere il dissenso, anche quando questo è tremendamente scomodo? Dovrebbe. Perché nel momento in cui il disaccordo e il dissenso solleticano impulsi bestiali e sollecitano lo schiacciamento del dissidente, allora ci si dovrebbe interrogare. Probabilmente quell’altro, nella recondita coscienza, non ha diritto di espressione, men che meno di contraddizione.
Allora si ha un problema di potere. Ma è lì che si annida la violenza: “ti elimino perché non mi obbedisci” è la non-logica del femminicida, così come di chiunque, non riuscendo a stare nel dissenso, passa all’eliminazione, anche solo di tipo morale o evitante, di chi dice “no”.
La possibilità concreta di dire “no”, “non voglio”, “non mi piace”, “non sono d’accordo”, “fammici pensare”, “stai sbagliando”, “parliamone”, senza subire conseguenze, indica lo stato di salute di qualsiasi relazione e ambiente. L’agibilità e la sicurezza di ogni spazio sociale risiedono nell’effettiva opportunità di praticare dissenso, senza per questo essere etichettati o perseguitati. E la sapienza di chi riveste ruoli di responsabilità sta nel custodire il disaccordo senza estemporanei tentativi di superarlo alla buona, per una sdolcinata etica pacifista o, peggio ancora, per auto-assolvimento.
La violenza di genere è il prodotto di una società che fatica nel passaggio a schemi educativi e relazionali puliti, in cui l’autorità non è data dal genere, dall’età, dal ruolo, ma dall’effettiva capacità di accrescere (come del resto la parola, dal latino augere, suggerisce) il valore di chi si ha di fronte.
Riflettere seriamente, criticamente, definitivamente su tutte le forme di violenza che ci affliggono significa lavorare concretamente anche sulla violenza di genere. Ma significa anche, soprattutto, aver capito il senso del femminismo: partire dalla condizione della donna, per allargarsi a chiunque soffra. E di minoranza in minoranza, di vittima in vittima, disinnescare qualsiasi trappola, disarmarsi, per non continuare a distruggersi.
Dunque, la donna, in particolare la vittima, sarebbe solo una “scusa” per parlare d’altro o, peggio, per cambiare discorso? No. È solo l’effetto della sofferenza vissuta autenticamente: empatizzare, aprirsi alle altre sofferenze, trasfigurare le cose mentre ci si trasforma nella differenza, rinunciando a rispondere con il male, mentre si interrompono i circoli della vittimizzazione e si inaugurano modi nuovi di esistere e mondi nuovi da abitare.












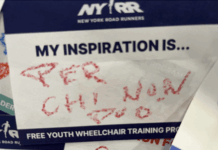




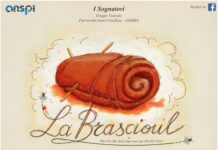









Bellissimo e profondo articolo.Andrebbe letto in ogni ordine di scuola e spiegato con semplicità ai più piccoli.
Grazie per questa bella riflessione!
Articolo profondo che andrebbe letto in ogni segmento di scuola.Mi auguro che quella di oggi non sia solo una giornata celebrativa , una semplice pagina di educazione civica.