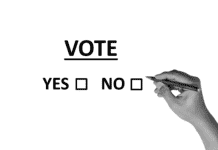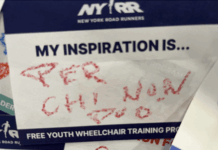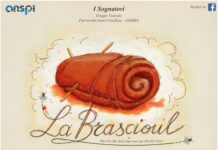La verità dietro i premi a pagamento
Nel panorama culturale italiano contemporaneo, i concorsi letterari rappresentano una realtà apparentemente in fermento. Dall’evento nazionale che porta in copertina gli autori noti fino al piccolo concorso di paese che si svolge nella sala della biblioteca comunale, ogni giorno vengono pubblicizzati bandi nuovi, inondando i social e i siti dedicati alla scrittura con promesse allettanti: “giuria di qualità”, “visibilità per i vincitori”, “possibilità di pubblicazione”, “evento prestigioso”. Ma dietro a questa facciata di entusiasmo si cela, troppo spesso, una realtà molto meno nobile e più opportunistica.
La maggior parte dei concorsi letterari, oggi, è a pagamento. Le cosiddette “spese di segreteria”, richieste per iscriversi, oscillano in media tra i 20 e i 50 euro. In certi casi si arriva anche oltre, con cifre che superano i 70 euro per partecipazione. Queste tariffe vengono giustificate con motivazioni che vanno dalla stampa dei materiali all’organizzazione dell’evento, fino alla “necessità di retribuire una giuria di alto livello”. Peccato che in molti casi, la giuria non venga affatto retribuita: spesso composta da volontari o da nomi piazzati lì per richiamo mediatico, senza un vero coinvolgimento. Alcuni giurati, per essere presenti alla cerimonia finale, devono persino pagarsi viaggio, pernottamento e spese personali.
La dinamica più diffusa e discutibile, però, resta quella della pubblicazione delle antologie. È ormai consuetudine che, a seguito del concorso, venga proposta agli autori selezionati l’inclusione dei propri testi in una raccolta stampata. Apparentemente è un’opportunità editoriale, ma in realtà si tratta spesso di una trappola commerciale: le poesie o i racconti pubblicati sono uno o due per autore, la cura redazionale è minima o assente, la diffusione è nulla e la vera finalità è vendere le copie agli stessi autori. A prezzi che variano dai 15 ai 25 euro a volume. Con “sconti” legati alla quantità: “Se acquista 8 copie ha diritto al 20%, con 16 copie uno spazio più ampio per la bio, con 32 copie una doppia pagina fotografica”. È un sistema che somiglia molto da vicino ai classici meccanismi del pay-to-win, dove la qualità dell’opera cede il passo alla disponibilità economica dell’autore.
La manipolazione si insinua sin dalle prime comunicazioni: email colme di lodi, iperboli e complimenti sperticati. “Il suo testo ci ha colpito per la sua profondità”, “raramente ci è capitato di leggere parole tanto potenti”, “la sua sensibilità è un dono per il lettore”. Frasi che appaiono identiche per decine di autori diversi, perché non sono davvero scritte dopo aver letto, ma fanno parte di un copione standardizzato, pensato per spingere all’acquisto.
Il sistema si regge su un ricatto emotivo ben calibrato: l’autore, spesso esordiente o insicuro, desidera sentirsi riconosciuto. Pubblicato. Vincente. E quando qualcuno ti dice che “sei stato selezionato tra centinaia”, che “il tuo testo verrà pubblicato in una prestigiosa raccolta”, che “la tua voce merita di essere ascoltata”, è facile cadere nel tranello, e convincersi che 80 o 100 euro spesi per comprare qualche copia siano il prezzo da pagare per un sogno.
Ma i problemi non si fermano all’antologia. In molti concorsi, soprattutto quelli più piccoli o gestiti da associazioni culturali, si assiste al fenomeno dell’“amicalismo”: premi assegnati ad amici, colleghi, ex allievi, o ad autori con un nome “spendibile” — non per reale notorietà, ma per appartenenza a un certo circuito. Lo scambio di favori è sottile, spesso non formalizzato, ma ben percepibile. In alcune realtà, gli stessi nomi compaiono ciclicamente: un anno come giurati, l’anno dopo come vincitori, poi di nuovo come ospiti o relatori. Un circolo chiuso che si autoalimenta.
Più il concorso mette in palio premi in denaro o visibilità, più si acuiscono queste dinamiche. Nei premi per libri editi, ad esempio, non è raro che venga premiato chi pubblica con la stessa casa editrice che organizza il concorso, o con una casa editrice “amica”. Quando non addirittura con una delle giurie coinvolte. Ed è sempre più frequente che i risultati vengano annunciati senza una vera graduatoria: solo “finalisti”, “segnalati”, “menzioni speciali”. Tutti ricevono un attestato, un foglio con il proprio nome, ma nessuno capisce davvero dove si sia posizionato. Così il giorno della cerimonia diventa una passerella: decine di autori che viaggiano, pagano albergo e cena, e tornano a casa con un diploma da incorniciare — o da riporre nel cassetto.
Ci sono anche i casi peggiori, in cui non viene nemmeno organizzata una cerimonia in presenza. Si paga per partecipare, e il concorso si conclude con una comunicazione via mail, una pagina Facebook, un PDF da stampare. Niente letture, niente confronto, niente pubblico. Solo una sensazione sgradevole, come quella di chi ha comprato un biglietto per un concerto e ha ricevuto un link su YouTube.
E mentre in Italia i concorsi proliferano — tra Rotary, Lions, parrocchie, circoli culturali, case editrici più o meno improvvisate — in altri Paesi come la Spagna, molti premi letterari sono rigorosamente gratuiti. Non per carenza di fondi, ma per rispetto. Perché un autore, prima di tutto, dovrebbe essere letto, e non pagante.
Il mondo editoriale non è esente da queste logiche. Accanto agli editori storici e indipendenti seri, c’è un universo di editori a pagamento che si aggancia a questi concorsi per costruire un mercato parallelo: pubblicazioni fatte in fretta, libri stampati con qualità grafica scadente, refusi ovunque, traduzioni approssimative. E, soprattutto, titoli venduti quasi esclusivamente agli stessi autori o ai loro amici. Alcuni di questi editori gestiscono decine di concorsi l’anno, “autopremiandosi” nei propri eventi, fingendo recensioni, rilasciando interviste tra soci e autori interni, creando un’apparente autorevolezza fondata sul nulla. La cosa peggiore, forse, è che questa cultura falsa e autoreferenziale, fatta di premi fasulli e visibilità illusoria, si sta sostituendo al lavoro vero della scrittura. Tanti autori passano da un concorso all’altro, da un attestato all’altro, da un’antologia all’altra, accumulando diplomi, riconoscimenti, fotografie con le coppe. Ma senza mai confrontarsi davvero con i lettori. Senza mai essere davvero letti.
La cultura non è questo. La poesia non ha bisogno di pacchetti promozionali. Un premio vero non si compra e non si elemosina: si conquista con il valore, oppure si rifiuta con dignità. La cultura vera la si riconosce nei contesti dove non ci sono passerelle, ma ascolto. Dove l’autore non è cliente, ma voce. Dove si coltiva il pensiero e non l’ego. Forse la vera rivoluzione culturale, oggi, sarebbe proprio questa: imparare a dire di no. A non pagare per partecipare, a non credere alle lusinghe, a non farsi comprare con un diploma stampato in serie. Rifiutare l’antologia con la poesia “potentissima”, rinunciare alla menzione se è ottenuta solo in cambio di un acquisto. Perché non è con un attestato che si costruisce un autore, ma con la lettura, il tempo, la dedizione, la verità. E se qualcuno un giorno dovesse premiare un testo davvero valido, lo farà senza chiedere nulla in cambio. E allora sì, sarà un premio che vale la pena accettare.