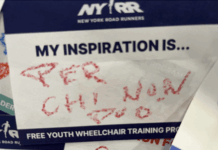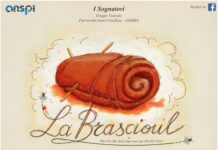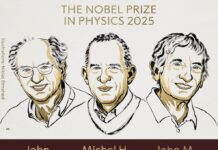di Roberta Di Canio
Nel suo poema “Sulla natura”, l’antico filosofo greco Parmenide racconta di essere giunto, dopo un lungo viaggio, davanti ad una “porta che divide i sentieri della Notte e del Giorno”, di cui la “Giustizia, che molto punisce, ha le chiavi che aprono e chiudono”.
Un’immagine che, ad ogni nuova lettura, comunica inesauribili e sempre attuali significati. Ma ce n’è uno, che in questo momento storico, immediatamente viene evocato. Innanzitutto la verità si dischiude solo ai giusti, poiché è la sete di giustizia che sprona ciascuno a cercare la verità. Così, infatti, scrive Parmenide: “Non è un potere maligno quello che ti ha condotto per questa via […] ma un divino comando e la Giustizia”. È vero però anche il contrario: la ricerca della verità, di cui il viaggio di Parmenide è metafora, conduce alla giustizia.
Ad ogni modo, non c’è giustizia senza verità, comunque si voglia intendere quest’ultima: come informazione o come libero e argomentato pensiero, purché plurale e complessa invece che unica e semplice o semplificata. La conoscenza è la condizione necessaria, sebbene non sufficiente, per cambiare il corso delle cose ed evitare che corruzione e ingiustizia abbiano la meglio. Viceversa, affinché la giustizia non spalanchi le sue porte basta tenere chiusa a chiave la verità.
Solo che a sbarrare questa porta non è la giustizia stessa ma il potere ingiusto. Questo, infatti, teme la verità, soprattutto quella declinata al plurale. Queste considerazioni appaiono così evidenti, quasi banali, che, per metterle alla prova, non c’è bisogno di scomodare personaggi del calibro di Socrate, Martin Luther King, Ghandi, Giacomo Matteotti, Massimiliano Maria Kolbe, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Ilaria Alpi, Giulio Regeni e perfino Alexei Anatolievich Navalny. Solo per fare qualche noto nome. Tutti passati a miglior vita per aver osato sfidare il potere ingiusto con la forza della verità. Senza contare tutti coloro la cui esistenza è appesa ad un filo perché vivono sotto scorta o sono rinchiusi come prigionieri politici dentro carceri disumane o sono banditi da paesi persecutori. Non basterebbe un articolo per elencarli.
La più temuta delle verità è quella che proviene dalla società civile, perché nelle democrazie è la base del consenso, senza il quale non c’è potere, e nei regimi autoritari è la base del dissenso, che può rovesciare i potenti. Il consenso e il dissenso, da parte loro, si costruiscono più spesso con le idee che con i fatti. Non foss’altro perché i fatti, pur essendo più tangibili delle idee e dunque apparentemente più oggettivi, hanno lo svantaggio di non parlare chiaramente da soli, di dover essere interpretati, di essere divorati dal tempo per la caducità della materia a cui sono legati. Invece le idee hanno il privilegio (nel bene e nel male) di insinuarsi di nascosto, di sfuggire alla vista, di informare di sé ogni cosa e soprattutto le coscienze dei presenti e dei posteri, senza che necessariamente se ne abbia consapevolezza.
È proprio per questa ragione che i potenti delle democrazie contemporanee tentano di controllare le idee più che il corpo delle persone. Non potendo usare impopolari e illegittimi strumenti di repressione del dissenso e di limitazione della libertà personale, essi preferiscono impadronirsi delle menti dei cittadini, lavorarle lentamente e silenziosamente attraverso il controllo dell’informazione, dell’istruzione e dell’educazione.
A tal fine sembrerebbe orientata la pubblica invettiva che i potenti frequentemente dirigono contro gli intellettuali. Essa, gettando discredito sulla loro autorevolezza, mediante la banalizzazione del pensiero, le offese personali, il disconoscimento (infondato) della competenza, ne limita l’influenza culturale.
È quanto sta accadendo quotidianamente sotto i nostri occhi. Recentemente il filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, dopo aver osato un’analisi – per nulla superficiale – delle tecniche comunicative della Presidente del Consiglio, è stato da lei pubblicamente attaccato e declassato a “filosofo da salotto”, con toni irosi e un linguaggio per nulla istituzionale. Lo scrittore Roberto Saviano, da anni sotto scorta per i suoi studi sulla mafia, è continuamente deriso e offeso dai nostri governanti.
Nel 2024 l’annullamento da parte della RAI del discorso dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile, per ragioni non ancora chiare, fu travolto da polemiche legate all’elevato compenso richiesto, come se quel discorso non fosse frutto di decenni di studi ma di impulsi ideologici di un cittadino di cultura media.
Più recentemente, la giurista e relatrice speciale ONU Francesca Albanese, attualmente bandita dal territorio degli Stati Uniti e colpita da pesanti sanzioni economiche americane, per i suoi rapporti sulla condizione dei diritti umani in Palestina, è stata considerata “di parte” dall’ambasciatore italiano alle Nazioni Unite Maurizio Massari. Come se denunciare il genocidio e le occupazioni illegali in Palestina, di cui lei stessa è stata testimone oculare, per incarico della stessa ONU, significhi fare politica invece che stare dalla parte della legalità, degli oppressi e della giustizia, appunto. A rincarare la dose, nella stessa occasione, ci ha pensato il rappresentante permanente di Israele, Danny Danon, che ha accusato la relatrice di diffondere idee antisemite e l’ha apostrofata con un termine al limite del risibile: “strega fallita”.
Non sono mancati neanche affronti alla storica Michela Ponzani la quale, secondo il generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, fautore, senza alcun titolo, di uno sgangherato e ignobile revisionismo storico del fascismo, avrebbe studiato su (fantomatici) libri del PD invece che sulle fonti storiche.
Ancora, dopo le rivelazioni di Report sui conflitti di interesse e sulle spese sconsiderate del Collegio del Garante della privacy, il Garante stesso ha rimproverato al conduttore Sigfrido Ranucci di aver mandato in onda “una puntata dei Teletubbies”.
Ma, a quanto pare, il male dell’invettiva personale dilaga anche oltreoceano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in occasione della partecipazione di Greta Thunberg alla Global Sumud Flotilla, del suo arresto illegale e dello scherno subito dai soldati israeliani a Gaza, ha definito questa giovane attivista “una piantagrane con problemi di gestione della rabbia. Una pazza”. Mentre giornalisti e docenti universitari scomodi sono accusati di diffondere fake news.
Si potrebbe continuare a lungo, ma la strategia comune a tutti questi ignobili attacchi è non confutare le idee degli intellettuali entrandovi nel merito, ma contestare la persona che le sostiene.
Questa delegittimazione dell’intellighenzia è già abbastanza grave da essere preoccupante, poiché è esercitata in una relazione asimmetrica tra l’intellettuale e il potere politico, che è decisamente più attrezzato per potersi difendere. Nonostante ciò, lascia il tempo che trova. Infatti intercetta due gruppi di cittadini in modo altrettanto inefficace: quello più acculturato e informato, sul quale non fa alcuna presa, e quello meno acculturato e meno informato, che nemmeno riesce a seguire la “disputa” e, al più, ne coglie il significato più grossolano di scontro violento, nel quale vince chi meglio riesce a parlare alla pancia invece che alla testa dei cittadini. In entrambi i casi l’esito è lo stesso: non avanzare di un passo nell’analisi e nella risoluzione dell’ingiustizia e dei problemi sociali, alimentando un pericoloso ma funzionale clima d’odio.
L’altra “chiave” che chiude la “porta” della verità consiste nell’agire sull’educazione dei giovani e sulla formazione di educatori e docenti limitandone la libertà di espressione, di informazione e di critica e trasmettendo nozioni, idee e valori solo apparentemente incontrovertibili e condivisi. Una strategia questa che ha l’amaro sapore di un passato nefasto e che dovrebbe far riflettere sulla precarietà della libertà e della democrazia, conquiste mai definitive e scontate. Ed è proprio nel passato che questa strategia si è rivelata più efficace. Essa, infatti, produce effetti duraturi e profondi dal momento che è in grado di creare una base sociale di cittadini obbedienti. Docili perché inconsapevoli di essere eterodiretti, e zelanti perché incarnano perfettamente gli ideali inoculati dal potere. La scuola, allora, potrebbe nuovamente diventare il terreno più fertile per il compimento di questo “capolavoro” politico.
È il caso del recente DDL 1627 in corso di discussione, a firma del senatore Maurizio Gasparri Esso, adottando pedissequamente la definizione di antisemitismo coniata nel 2015 dall’organizzazione intergovernativa IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) equipara, nella sostanza, l’antisionismo all’antisemitismo, con la conseguenza di semplificare pericolosamente due fenomeni storici assai complessi e diversi. Il DDL si spinge fino a prevedere sanzioni penali, da irrogare su delazione, per chiunque manifesti a scuola idee antisioniste. Inoltre prevede l’istituzione di corsi di formazione anche per docenti e studenti al fine di contrastare entrambi i fenomeni. Come scrive il Coordinamento Docenti dell’Università di Bologna, in collaborazione con altri gruppi: “Tutto questo è molto pericoloso perché in questo modo si confonde un crimine d’odio, come l’antisemitismo, ancora vivo nel nostro paese e da contrastare, con la critica a un progetto di colonialismo di insediamento che si è espresso mediante la sistematica infrazione del diritto internazionale. Di conseguenza, sarà anche più difficile individuare e agire sui reali casi di antisemitismo. Ribadiamo che non c’è nulla di “ebraico” nel colonialismo, nell’apartheid, nello “scolasticidio” e nel genocidio, commessi da Israele verso il popolo palestinese. Per questo contrastare le politiche violente e razziste di Israele oggi non può essere considerato una forma di antisemitismo. Critiche al sionismo, tra l’altro, provengono anche dal mondo ebraico e sono centrali nel pensiero di intellettuali ebrei che consideriamo tra i fondatori della nostra riflessione sulla Shoah, come Hannah Arendt e Primo Levi. Se questa legge entrasse in vigore, anche questi autori finirebbero per essere tacciati di antisemitismo”. Compresa la storica Anna Foa, il cui ultimo libro, “Il suicidio di Israele”, ha già un titolo eloquente.
Per queste strade, repressione del dissenso e costruzione del consenso mediante la semplificazione della verità diventano formidabili strumenti di intorpidimento delle coscienze e, conseguentemente, di inibizione di ogni forma di mobilitazione civica contro l’ingiustizia.
Ma la storia insegna anche che niente può assopire quella che il filosofo Immanuel Kant chiamava la “naturale disposizione” della ragione umana alla conoscenza. Il dubbio metodico e la sete di verità restano, pertanto, antidoti efficaci contro il potere ingiusto. Come afferma Parmenide, il carro su cui viaggia il cercatore della verità può abbandonare il sentiero della notte e intraprendere quello del giorno solo se trainato da un naturale e inestirpabile desiderio umano di conoscenza. E questo viaggio, precisa il filosofo, è tanto lungo quanto l’animo può desiderare.
In questi tempi così bui, c’è dunque ancora speranza, quella speranza che la relatrice ONU Francesca Albanese sostiene di continuare ancora a coltivare, pur pagando un prezzo personale altissimo, motivata com’è dalla grande mobilitazione dal basso a cui si sta assistendo, una mobilitazione che definisce un’“importante azione di cittadinanza attiva, che apporta un senso nuovo alla diplomazia”. Perché, scrive nel suo ultimo libro “Inside”, “una società che rinuncia al diritto è una società che si condanna alla violenza. Io, in una società simile, mi rifiuto di vivere e di lasciarla in eredità ai miei figli. E ai vostri”.
DISCLAIMER:
Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente dell’autrice e non riflettono in alcun modo la posizione ufficiale della testata né di alcuna istituzione scolastica.
Il contenuto è pubblicato a titolo di libera manifestazione del pensiero, nel rispetto dell’art. 21 della Costituzione italiana.